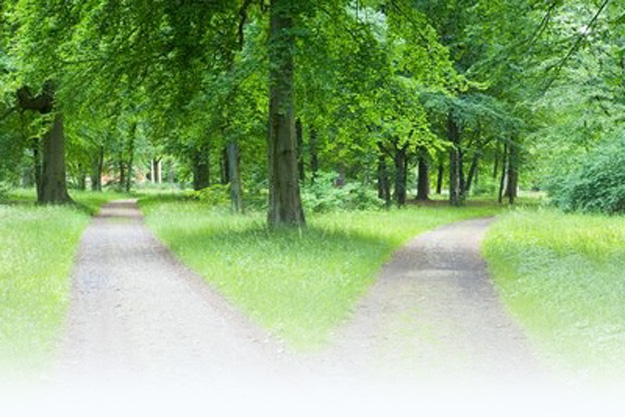VITA (GAY) DEGLI ANNI '50
- progettogayforum
- Amministratore
- Messaggi: 5980
- Iscritto il: sabato 9 maggio 2009, 22:05
VITA (GAY) DEGLI ANNI '50
Ringrazio sentitamente un amico che ho avuto l’opportunità di conoscere tramite questo forum per aver scritto un articolo veramente bellissimo sulla vita degli anni ’50 e su come crescevano i ragazzi in quell’epoca. In questo modo tanti ragazzi di oggi potranno capire come hanno vissuto i loro padri e i loro nonni. Devo dire che questo articolo mi ha veramente colpito perché, anche se sono cresciuto in citta, e quindi in un ambiente diverso, ci ritrovo molte atmosfere della mia infanzia.
_______
Ho scoperto questo sito da pochi mesi ma, da allora, l’ho seguito con molto interesse. Molti post mi hanno portato a riflettere su me stesso, in alcuni casi su quanto sia tiepido, soprattutto in campo religioso ma non solo. Ho avuto una corrispondenza con Project. Ritiene interessante che si parli di cosa era essere gay negli anni ’60 ed essendo io molto in là negli anni, che io possa dire qualche cosa al riguardo. Non sono sicuro di essere in grado di fare una cosa simile. Non è solo che non mi sono mai dichiarato: non ho praticamente mai frequentato ambienti o avuto scambi di opinioni con altri gay. Prenderò quindi la faccenda molto alla lontana. Tutto quello che dirò si basa molto più su miei preconcetti che su cose che sarei in grado di provare. E sarò noioso.
Per i miei primi dieci o undici anni, sono cresciuto in un paese abbastanza piccolo, soprattutto in un grande cortile in cui vivevano le famiglie di mio nonno e dei suoi fratelli, e dei relativi figli e nipoti. Avete visto Novecento, atto I? Saremo stati una cinquantina di noi, con gli altri, si arrivava quasi al centinaio. È difficile per un ragazzo, ma anche per chi è sui quaranta, soprattutto se cresciuto in città, rendersi conto di quel che ciò comporta. Sei mesi prima, sei mesi dopo di me sono nati altri sei o sette cugini. Siamo cresciuti assieme, giocando in cortile, soprattutto nei prati e nei boschi circostanti, lontano dagli occhi dei genitori. Non è che non si curassero di noi, anche se credo che il padre cominciasse a parlare veramente con i figli quando questi erano già grandicelli, quando cominciavano a lavorare, ossia verso gli undici o dodici anni. Non c’era bisogno di sorveglianza. In paese, fino a metà anni ’50, c’era una sola macchina, una Balilla degli anni ’30 che si avviava ancora a manovella e le poche volte in cui veniva messa in moto erano eventi a cui tutti i bambini volevano essere presenti. Non c’erano grandi pericoli e i genitori potevano essere tranquilli anche perché, pur nei campi, se si cominciava a fumare le prime si-garette, si era sicuri che qualcuno l’avrebbe visto e l’avrebbe detto ai nostri, con le inevitabili ramanzine. Io no (una mia zia, per altro piissima, riteneva che la cosa inducesse a diventare villani e screanzati) ma i miei cugini erano tutti chierichetti. Andavamo tutti all’oratorio ma, pur andando a messa e facendo la comunione, non sono sicuro che ci sentissimo parte della Chiesa. Credo di essere abbastanza religioso e, per quel che riesco, cattolico ma, forse perché mi sono formato in ambiente pre-Concilio, questo è cosa molto diversa dal sentirsi parte della Chiesa, almeno da come traspare da al-cune delle cose scritte in vari post. L’oratorio, in genere riservato alla domenica pomeriggio, era soprattutto il posto in cui si giocava a calcio (io non tanto perché avevo un gioco troppo “maschio”), a ping pong, a calciobalilla e si imparava a giocare a carte (io sapevo giocare benissimo a scala quaranta). Capitava anche ogni tanto che qualcuno più grande ci facesse catechismo. Non so perché, ma li consideravamo figure un po’ patetiche e noiose. Di “religioso” c’era solo una benedizione che durava cinque minuti.
La tradizione era che si andasse all’oratorio fin verso i dodici o tredici anni: restarci oltre sembrava segno di mancata cottura. Poi, per la maggior parte degli uomini, sicuramente c’era la messa domenicale. Si dicevano quattro messe la mattina della domenica e la chiesa era sempre piena. Ma, per il 90% degli uomini adulti, la comunione si faceva tre volte l’anno: ai morti, a Natale e a Pasqua. Allora, la distanza tra il clero ed i fedeli era abissale, dal punto di vista culturale, in primo luogo, ma anche come divisione di compiti e di ruoli.
Quanto incideva la predicazione della Chiesa? Secondo me, ma può darsi che la mia visione sia di-storta, sapendo che i fedeli si sarebbero rivisti raramente, quello su cui si insisteva era la formazione della coscienza individuale. L’atteggiamento dei fedeli nei confronti dei preti era riassunto nel detto: “Fate quel che dico io ma non quel che faccio io”, da un lato, e “Anima tua, borsa tua”, dall’altro. Era una chiesa che, mentre occupava un grandissimo spazio nel sociale, dagli asili agli ospedali, le scuole, gli orfanatrofi, le prigioni, ecc., predicava molto poco sul sociale. Si insisteva ancora sul detto di San Paolo: “Chi non lavora, neppure mangi”. La religiosità, almeno un certo tipo di religiosità, era comunque molto forte.
Secondo me, questo era legato al fatto di quanto fosse presente la morte. La mortalità infantile era ancora alta e, quando moriva un bambino, le suore portavano tutti al loro funerale, seguendo la pro-cessione fino al cimitero. E i cimiteri avevano ancora una sezione in cui si seppellivano i bambini. Se ci si ammalava seriamente, non ci si aspettava molto di guarire. Si moriva, come si nasceva, in casa. Non c’erano imprese di pompe funebri. La cassa la faceva uno dei falegnami del paese. Il morto veniva lavato e vestito dai suoi parenti. Si diceva il rosario a casa del morto e il lutto era preso molto sul serio. Soprattutto, si credeva nel giudizio individuale, prima e più che in quello universale, nell’inferno e nel purgatorio, forse di più che nel paradiso. Ovviamente, la mia esperienza riflette un ambiente forse particolare, ma non troppo.
Fino agli anni ’50, la popolazione urbana arrivava forse al 20 o 30%, l’agricoltura era il 60% e forse più dell’economia italiana. Nell’Italia centro-settentrionale, questa era basata sulla piccola proprietà e sulla mezzadria. L’occupazione nell’industria e nei servizi era ancora abbastanza limitata e comunque non c’erano grossi problemi di disoccupazione, anche se l’occupazione in fabbrica cominciava ad avere effetti dirompenti sull’assetto sociale ed economico esistente. Sia che si lavorasse in proprio, in agricoltura in particolare, sia nelle imprese, si vedeva e si misurava il risultato del proprio lavoro, anche se, in agricoltura, più del lavoro della famiglia che del singolo.
Certo, quanto valeva ciò che si era prodotto dipendeva poi dal mercato, e dalla fortuna col tempo in agricoltura. Ma c’era un’obiettività nella misura di cosa si era fatto, cosa era dovuto a sé, di quanto si era o non si era stati capaci di fare, che dava una consapevolezza delle proprie capacità e dei propri limiti che è andata largamente persa. Oggi si è molto più spinti a comparare quel che succede a sé con quel che succede ad altri, e quel che succede a ciascuno è basato su cose difficilmente osservabili dagli altri, in particolare quanto ciascuno ha effettivamente “prodotto”, per cui è più facile attribuire la diversità dei gradi di “successo” ad elementi casuali e a criticare la “giustizia” dell’assetto raggiunto. Quando quel che si ottiene dipende da quel che si fa, l’ottica, il peso del senso di responsabilità, è molto diversa.
Simultaneamente a questo cambiamento, ma forse paradossalmente, è cambiato ciò che si chiede al lavoro. Allora la soddisfazione dipendeva non tanto dal tipo di lavoro che si faceva, in cosa consistesse, quanto consentisse di “realizzarsi”, ma dall’essere in grado di mantenere la propria famiglia. E la famiglia era tutta un’altra cosa. Non alludo a divorzi, convivenze od altro che non c’erano ma al fatto che viveva producendo molto di quello che serviva e consumava per la propria sussistenza e, da questo punto di vista la famiglia poggiava soprattutto sul lavoro delle donne. Gran parte del “reddito”, certo non monetario (e perciò esentasse), era prodotto da loro, col lavare, cucinare, cuci-re, pulire, curare i vecchi ed i malati, oltre ad aiutare nei campi e tirar su i figli.
Credo che soprattutto i sociologi ma anche gli economisti e gli storici economici abbiano scritto moltissimo su come è cambiato il matrimonio e la famiglia ma purtroppo non conosco la letteratura rilevante. Fino a quando quel tipo di società è sopravvissuta c’erano grandi vantaggi, e altrettanto grandi costi, nel differenziare il ruolo dell’uomo e della donna. Ci si sposava tra persone dotate di abilità diverse (oggi le ragioni economiche spingono in direzione opposta) e ci si distribuivano i compiti in maniera da dipendere il meno possibile dal mercato, dal dover comperare ciò di cui si aveva bisogno. Finita la scuola, d’estate, le bambine andavano dalle suore ad imparare taglio, cucito e ricamo, oltre a recitare il rosario e le litanie della Madonna. Fino agli anni ’60, le riviste di moda avevano i cartamodelli, con cui tagliare e farsi i vestiti da sole. Per i vestiti più impegnativi, però, c’erano in paese delle sarte. Quando eravamo poveri, ci permettevamo vestiti su misura, sia pure so-lo per le occasioni eccezionali, per la prima comunione, i matrimoni, ecc. L’istruzione delle donne, soprattutto se a scapito dell’acquisizione delle altre abilità, le ostacolava dal punto di vista matrimoniale. Ci si sposava per amore? Si, ma non senza aver considerato tutto il resto.
Con chi ci si sposava? In genere all’interno dello stesso paese, il che creava legami di parentela fortissimi. Non si era solo Tizio, Caio o Sempronio, ma si era il figlio di, lo zio di, il cugino di. L’ambito del “privato” era molto ristretto. Si cominciava col fatto che la casa, in gran parte dei casi, consisteva nella cucina ed una camera da letto, sufficientemente grande da contenere il letto in cui dormivano genitori, quello in cui dormivano i figli e quello delle figlie (il figlio unico era una rarità). E questo solo dopo gli anni ’30, perché prima anche la cucina era unica, per il capofamiglia, i figli e le mogli dei figli; solo le stanze da letto erano separate. A parte il mangiare, quando non si stava lavorando, si viveva gran parte del giorno nel cortile. I momenti critici delle famiglie arriva-vano alla morte del capostipite, quando ci si doveva dividere la scarsa eredità.
Nei rapporti tra le famiglie e le singole persone non si usava mai la violenza, almeno quella vera. Qualche volta, raramente e con grande scandalo, si veniva alle mani, in genere all’osteria, da ubriachi. Ma nel mio paese non c’erano carabinieri o polizia, al massimo il messo comunale, ma non c’era neppure la posta ed il medico, per chi era iscritto alla mutua, arrivava un paio di giorni dopo che si era lasciato un biglietto nell’apposita buca posta sulla piazza della chiesa.
Soprattutto, quasi tutto quello che si faceva era osservabile dagli altri e tutti avevano più o meno la stessa informazione su tutti: non si potevano avere “identità” diverse a seconda degli ambienti e delle persone che si frequentavano, se non per aspetti piuttosto limitati. Si era accettati o rifiutati non per un aspetto, ma per il complesso della persona che si era, anche se c’erano aspetti a cui si dava più peso e ad altri meno. E la collettività era molto esigente. Nel mio paese, allora, su tremila perso-ne ci saranno stati cinque o sei tra ragionieri, geometri o maestre ma, più che per il loro titolo di studio, venivano valutati per la loro capacità di risolvere problemi, di aiutare concretamente gli altri nei loro casi: se uno falliva in quello, veniva considerato un cretino, uno che era andato a scuola per diventare scemo. Non si valutavano le scuole ma quel che uno aveva imparato sì.
Cosa poteva voler dire esser gay in quell’ambiente? Era possibile pensarsi gay? Forse sì, ma in maniera molto diversa da quella di oggi. Ho lasciato il mio paese verso i dieci anni, per cui quel che dirò è supposizione mia e storia forse strettamente personale, non so quanto comune. Data la separazione tra maschi e femmine, persino all’asilo e alle scuole elementari, un po’ di esperienze vaga-mente omoerotiche, ovviamente molto limitate e soft, erano abbastanza comuni. Non che non si giocasse al dottore anche con le bambine, ma nella mia esperienza erano cose molto limitate. Nel mio caso c’era un mio cugino con cui, se fossi rimasto e fossi stato meno pauroso, ci sarebbe potuto essere qualcosa di più. Ma, in un paese piccolo, la probabilità di trovare un altro gay più o meno della stessa età era molto bassa e raramente si usciva dal proprio paese. Anche da grandi, l’unico mezzo di trasporto era la bicicletta. Le corriere c’erano solo il mattino e la sera, per portare la gente al lavoro o i pochi ragazzi che continuavano a studiare a scuola. Non credo che ci fossero la domenica.
Suppongo che nessuno neppure pensasse alla possibilità di trovare qualcun altro con cui condivide-re tutta la propria vita, con cui mettere su famiglia. Non credo che questo fosse tanto l’effetto della morale sessuale della Chiesa. Allora, come oggi, credo ci fosse un giudizio fortemente negativo sull’omosessualità, ma dubiterei del legame mono-causale con la predicazione della Chiesa, anche se certamente questa rafforzava il pregiudizio. Per quanto forte il cattolicesimo, l’Italia si distingueva dall’Inghilterra o dalla Germania per non a-ver inserito l’omosessualità tra i reati puniti penalmente e i gay di quei paesi venivano in Italia a cercare quel che più tardi si sarebbe cercato a Mykonos. E la forza del dettato della Chiesa è svaporato in altri ambiti abbastanza in fretta. Quand’io ero bambino, sulla porta del confessionale c’era l’ammonimento che gli iscritti ai partiti comunisti e socialisti erano sotto pena di esclusione dai sacramenti ma i risultati elettorali dicono quanto la presa della Chiesa in campo politico sia venuta meno abbastanza rapidamente. In fatto di separazioni e divorzi, convivenze, nascite prima del matrimonio, ecc., negli ultimi venti o trenta anni l’irrilevanza o la scarsa incidenza della predicazione è ancora più ovvia.
Può darsi che sia semplicemente un’idiosincrasia ma mi incuriosisce molto quel che mi sembra distinguere l’effetto sui gay rispetto a quello sugli etero della precettistica cattolica. La condanna della masturbazione valeva per tutti ma non aveva, credo, lo stesso effetto. Io, ma in questo non credo di essere un caso unico o raro, l’ho sempre associata allo sporco, all’indecente e l’idea, per quanto cerchi di rimuoverla, rimane. Negli etero qualcosa di simile c’è ma è accompagnata dal fatto che è quel che tutti fanno, che è normale che un etero si comporti così, purché sia accompagnata da fantasie “normali”. Per un gay, le fantasie non lo sono altrettanto e sono difficilmente confessabili. A cosa serva il sesso, per un etero è ovvio. Per un gay invece c’è sempre il bisogno di chiedersi il perché, il perché di questi desideri, e non solo perché capitano a me. Anche questa può essere un’idiosincrasia. A me, come si fanno i bambini è stato detto dai miei compagni verso i cinque o sei anni, mi ricordo, mentre giocavamo nei boschi. La cosa mi è sembrata incredibile ed insensata. Perché diavolo si doveva fare così, perché fare così facesse nascere un bambino? Credo che per un etero accettare le cose come sono, soprattutto in questo campo, sia forse più facile. Ha tutta una platea di uguali che accettano le stesse cose. Per un gay questo non è vero, deve trovare ragioni proprie. E questo rovello sulle ragioni per me non è mai finito.
Si può dire tutto sulla naturalità e sul bisogno di provare piacere ma non so se è una ragione sufficiente. Ci sono un sacco di piaceri a cui si rinuncia. Perché non a questo? Forse è questa ricerca di perché, il non accettare le cose come sono semplicemente perché sono così, che fissa noi gay su una morale che agli altri entra da un orecchio ed esce dall’altro senza aver prodotto alcun effetto. Era soprattutto la pressione sociale ed il bisogno a spingere anche i gay a sposarsi. Non sono sicuro che il non sposarsi venisse condannato come sintomo di omosessualità, credo venisse usato molto più come indicatore di incapacità o non volontà di assumersi responsabilità e quindi di scarsa affidabilità e consistenza e perciò fatto oggetto di biasimo. Purtroppo non ho frequentato osterie e bar, in cui avrei potuto sentire cosa si diceva degli altri, né mi ricordo di qualcuno ovviamente gay e non so a quali fonti uno potrebbe rifarsi per farsi un’idea fattuale in proposito. Credo che fosse rarissimo che un gay si dichiarasse ma non mi ricordo di qualcuno che venisse etichettato come tale, anche perché, prima o poi, finiva per sposarsi. L’invisibilità, anche per la Chiesa, basta. E allora il costo di sposarsi per un gay era più basso di oggi: l’unica alternativa era vivere soli.
Non sposarsi, non fare figli era un allentare i legami col resto della comunità rispetto al comporta-mento comune e questo, già di per sé, veniva visto male. Ma era soprattutto mettersi in condizioni di vita difficili, che si fosse gay o meno. Fino a quando vivevano i genitori, si poteva stare in famiglia. Dopo, si doveva provvedere da sé a tutti i lavori “domestici”, quelli che sarebbero stati fatti da una moglie, e questo poteva mettere materialmente ed economicamente in una condizione assai difficile.
_______
Ho scoperto questo sito da pochi mesi ma, da allora, l’ho seguito con molto interesse. Molti post mi hanno portato a riflettere su me stesso, in alcuni casi su quanto sia tiepido, soprattutto in campo religioso ma non solo. Ho avuto una corrispondenza con Project. Ritiene interessante che si parli di cosa era essere gay negli anni ’60 ed essendo io molto in là negli anni, che io possa dire qualche cosa al riguardo. Non sono sicuro di essere in grado di fare una cosa simile. Non è solo che non mi sono mai dichiarato: non ho praticamente mai frequentato ambienti o avuto scambi di opinioni con altri gay. Prenderò quindi la faccenda molto alla lontana. Tutto quello che dirò si basa molto più su miei preconcetti che su cose che sarei in grado di provare. E sarò noioso.
Per i miei primi dieci o undici anni, sono cresciuto in un paese abbastanza piccolo, soprattutto in un grande cortile in cui vivevano le famiglie di mio nonno e dei suoi fratelli, e dei relativi figli e nipoti. Avete visto Novecento, atto I? Saremo stati una cinquantina di noi, con gli altri, si arrivava quasi al centinaio. È difficile per un ragazzo, ma anche per chi è sui quaranta, soprattutto se cresciuto in città, rendersi conto di quel che ciò comporta. Sei mesi prima, sei mesi dopo di me sono nati altri sei o sette cugini. Siamo cresciuti assieme, giocando in cortile, soprattutto nei prati e nei boschi circostanti, lontano dagli occhi dei genitori. Non è che non si curassero di noi, anche se credo che il padre cominciasse a parlare veramente con i figli quando questi erano già grandicelli, quando cominciavano a lavorare, ossia verso gli undici o dodici anni. Non c’era bisogno di sorveglianza. In paese, fino a metà anni ’50, c’era una sola macchina, una Balilla degli anni ’30 che si avviava ancora a manovella e le poche volte in cui veniva messa in moto erano eventi a cui tutti i bambini volevano essere presenti. Non c’erano grandi pericoli e i genitori potevano essere tranquilli anche perché, pur nei campi, se si cominciava a fumare le prime si-garette, si era sicuri che qualcuno l’avrebbe visto e l’avrebbe detto ai nostri, con le inevitabili ramanzine. Io no (una mia zia, per altro piissima, riteneva che la cosa inducesse a diventare villani e screanzati) ma i miei cugini erano tutti chierichetti. Andavamo tutti all’oratorio ma, pur andando a messa e facendo la comunione, non sono sicuro che ci sentissimo parte della Chiesa. Credo di essere abbastanza religioso e, per quel che riesco, cattolico ma, forse perché mi sono formato in ambiente pre-Concilio, questo è cosa molto diversa dal sentirsi parte della Chiesa, almeno da come traspare da al-cune delle cose scritte in vari post. L’oratorio, in genere riservato alla domenica pomeriggio, era soprattutto il posto in cui si giocava a calcio (io non tanto perché avevo un gioco troppo “maschio”), a ping pong, a calciobalilla e si imparava a giocare a carte (io sapevo giocare benissimo a scala quaranta). Capitava anche ogni tanto che qualcuno più grande ci facesse catechismo. Non so perché, ma li consideravamo figure un po’ patetiche e noiose. Di “religioso” c’era solo una benedizione che durava cinque minuti.
La tradizione era che si andasse all’oratorio fin verso i dodici o tredici anni: restarci oltre sembrava segno di mancata cottura. Poi, per la maggior parte degli uomini, sicuramente c’era la messa domenicale. Si dicevano quattro messe la mattina della domenica e la chiesa era sempre piena. Ma, per il 90% degli uomini adulti, la comunione si faceva tre volte l’anno: ai morti, a Natale e a Pasqua. Allora, la distanza tra il clero ed i fedeli era abissale, dal punto di vista culturale, in primo luogo, ma anche come divisione di compiti e di ruoli.
Quanto incideva la predicazione della Chiesa? Secondo me, ma può darsi che la mia visione sia di-storta, sapendo che i fedeli si sarebbero rivisti raramente, quello su cui si insisteva era la formazione della coscienza individuale. L’atteggiamento dei fedeli nei confronti dei preti era riassunto nel detto: “Fate quel che dico io ma non quel che faccio io”, da un lato, e “Anima tua, borsa tua”, dall’altro. Era una chiesa che, mentre occupava un grandissimo spazio nel sociale, dagli asili agli ospedali, le scuole, gli orfanatrofi, le prigioni, ecc., predicava molto poco sul sociale. Si insisteva ancora sul detto di San Paolo: “Chi non lavora, neppure mangi”. La religiosità, almeno un certo tipo di religiosità, era comunque molto forte.
Secondo me, questo era legato al fatto di quanto fosse presente la morte. La mortalità infantile era ancora alta e, quando moriva un bambino, le suore portavano tutti al loro funerale, seguendo la pro-cessione fino al cimitero. E i cimiteri avevano ancora una sezione in cui si seppellivano i bambini. Se ci si ammalava seriamente, non ci si aspettava molto di guarire. Si moriva, come si nasceva, in casa. Non c’erano imprese di pompe funebri. La cassa la faceva uno dei falegnami del paese. Il morto veniva lavato e vestito dai suoi parenti. Si diceva il rosario a casa del morto e il lutto era preso molto sul serio. Soprattutto, si credeva nel giudizio individuale, prima e più che in quello universale, nell’inferno e nel purgatorio, forse di più che nel paradiso. Ovviamente, la mia esperienza riflette un ambiente forse particolare, ma non troppo.
Fino agli anni ’50, la popolazione urbana arrivava forse al 20 o 30%, l’agricoltura era il 60% e forse più dell’economia italiana. Nell’Italia centro-settentrionale, questa era basata sulla piccola proprietà e sulla mezzadria. L’occupazione nell’industria e nei servizi era ancora abbastanza limitata e comunque non c’erano grossi problemi di disoccupazione, anche se l’occupazione in fabbrica cominciava ad avere effetti dirompenti sull’assetto sociale ed economico esistente. Sia che si lavorasse in proprio, in agricoltura in particolare, sia nelle imprese, si vedeva e si misurava il risultato del proprio lavoro, anche se, in agricoltura, più del lavoro della famiglia che del singolo.
Certo, quanto valeva ciò che si era prodotto dipendeva poi dal mercato, e dalla fortuna col tempo in agricoltura. Ma c’era un’obiettività nella misura di cosa si era fatto, cosa era dovuto a sé, di quanto si era o non si era stati capaci di fare, che dava una consapevolezza delle proprie capacità e dei propri limiti che è andata largamente persa. Oggi si è molto più spinti a comparare quel che succede a sé con quel che succede ad altri, e quel che succede a ciascuno è basato su cose difficilmente osservabili dagli altri, in particolare quanto ciascuno ha effettivamente “prodotto”, per cui è più facile attribuire la diversità dei gradi di “successo” ad elementi casuali e a criticare la “giustizia” dell’assetto raggiunto. Quando quel che si ottiene dipende da quel che si fa, l’ottica, il peso del senso di responsabilità, è molto diversa.
Simultaneamente a questo cambiamento, ma forse paradossalmente, è cambiato ciò che si chiede al lavoro. Allora la soddisfazione dipendeva non tanto dal tipo di lavoro che si faceva, in cosa consistesse, quanto consentisse di “realizzarsi”, ma dall’essere in grado di mantenere la propria famiglia. E la famiglia era tutta un’altra cosa. Non alludo a divorzi, convivenze od altro che non c’erano ma al fatto che viveva producendo molto di quello che serviva e consumava per la propria sussistenza e, da questo punto di vista la famiglia poggiava soprattutto sul lavoro delle donne. Gran parte del “reddito”, certo non monetario (e perciò esentasse), era prodotto da loro, col lavare, cucinare, cuci-re, pulire, curare i vecchi ed i malati, oltre ad aiutare nei campi e tirar su i figli.
Credo che soprattutto i sociologi ma anche gli economisti e gli storici economici abbiano scritto moltissimo su come è cambiato il matrimonio e la famiglia ma purtroppo non conosco la letteratura rilevante. Fino a quando quel tipo di società è sopravvissuta c’erano grandi vantaggi, e altrettanto grandi costi, nel differenziare il ruolo dell’uomo e della donna. Ci si sposava tra persone dotate di abilità diverse (oggi le ragioni economiche spingono in direzione opposta) e ci si distribuivano i compiti in maniera da dipendere il meno possibile dal mercato, dal dover comperare ciò di cui si aveva bisogno. Finita la scuola, d’estate, le bambine andavano dalle suore ad imparare taglio, cucito e ricamo, oltre a recitare il rosario e le litanie della Madonna. Fino agli anni ’60, le riviste di moda avevano i cartamodelli, con cui tagliare e farsi i vestiti da sole. Per i vestiti più impegnativi, però, c’erano in paese delle sarte. Quando eravamo poveri, ci permettevamo vestiti su misura, sia pure so-lo per le occasioni eccezionali, per la prima comunione, i matrimoni, ecc. L’istruzione delle donne, soprattutto se a scapito dell’acquisizione delle altre abilità, le ostacolava dal punto di vista matrimoniale. Ci si sposava per amore? Si, ma non senza aver considerato tutto il resto.
Con chi ci si sposava? In genere all’interno dello stesso paese, il che creava legami di parentela fortissimi. Non si era solo Tizio, Caio o Sempronio, ma si era il figlio di, lo zio di, il cugino di. L’ambito del “privato” era molto ristretto. Si cominciava col fatto che la casa, in gran parte dei casi, consisteva nella cucina ed una camera da letto, sufficientemente grande da contenere il letto in cui dormivano genitori, quello in cui dormivano i figli e quello delle figlie (il figlio unico era una rarità). E questo solo dopo gli anni ’30, perché prima anche la cucina era unica, per il capofamiglia, i figli e le mogli dei figli; solo le stanze da letto erano separate. A parte il mangiare, quando non si stava lavorando, si viveva gran parte del giorno nel cortile. I momenti critici delle famiglie arriva-vano alla morte del capostipite, quando ci si doveva dividere la scarsa eredità.
Nei rapporti tra le famiglie e le singole persone non si usava mai la violenza, almeno quella vera. Qualche volta, raramente e con grande scandalo, si veniva alle mani, in genere all’osteria, da ubriachi. Ma nel mio paese non c’erano carabinieri o polizia, al massimo il messo comunale, ma non c’era neppure la posta ed il medico, per chi era iscritto alla mutua, arrivava un paio di giorni dopo che si era lasciato un biglietto nell’apposita buca posta sulla piazza della chiesa.
Soprattutto, quasi tutto quello che si faceva era osservabile dagli altri e tutti avevano più o meno la stessa informazione su tutti: non si potevano avere “identità” diverse a seconda degli ambienti e delle persone che si frequentavano, se non per aspetti piuttosto limitati. Si era accettati o rifiutati non per un aspetto, ma per il complesso della persona che si era, anche se c’erano aspetti a cui si dava più peso e ad altri meno. E la collettività era molto esigente. Nel mio paese, allora, su tremila perso-ne ci saranno stati cinque o sei tra ragionieri, geometri o maestre ma, più che per il loro titolo di studio, venivano valutati per la loro capacità di risolvere problemi, di aiutare concretamente gli altri nei loro casi: se uno falliva in quello, veniva considerato un cretino, uno che era andato a scuola per diventare scemo. Non si valutavano le scuole ma quel che uno aveva imparato sì.
Cosa poteva voler dire esser gay in quell’ambiente? Era possibile pensarsi gay? Forse sì, ma in maniera molto diversa da quella di oggi. Ho lasciato il mio paese verso i dieci anni, per cui quel che dirò è supposizione mia e storia forse strettamente personale, non so quanto comune. Data la separazione tra maschi e femmine, persino all’asilo e alle scuole elementari, un po’ di esperienze vaga-mente omoerotiche, ovviamente molto limitate e soft, erano abbastanza comuni. Non che non si giocasse al dottore anche con le bambine, ma nella mia esperienza erano cose molto limitate. Nel mio caso c’era un mio cugino con cui, se fossi rimasto e fossi stato meno pauroso, ci sarebbe potuto essere qualcosa di più. Ma, in un paese piccolo, la probabilità di trovare un altro gay più o meno della stessa età era molto bassa e raramente si usciva dal proprio paese. Anche da grandi, l’unico mezzo di trasporto era la bicicletta. Le corriere c’erano solo il mattino e la sera, per portare la gente al lavoro o i pochi ragazzi che continuavano a studiare a scuola. Non credo che ci fossero la domenica.
Suppongo che nessuno neppure pensasse alla possibilità di trovare qualcun altro con cui condivide-re tutta la propria vita, con cui mettere su famiglia. Non credo che questo fosse tanto l’effetto della morale sessuale della Chiesa. Allora, come oggi, credo ci fosse un giudizio fortemente negativo sull’omosessualità, ma dubiterei del legame mono-causale con la predicazione della Chiesa, anche se certamente questa rafforzava il pregiudizio. Per quanto forte il cattolicesimo, l’Italia si distingueva dall’Inghilterra o dalla Germania per non a-ver inserito l’omosessualità tra i reati puniti penalmente e i gay di quei paesi venivano in Italia a cercare quel che più tardi si sarebbe cercato a Mykonos. E la forza del dettato della Chiesa è svaporato in altri ambiti abbastanza in fretta. Quand’io ero bambino, sulla porta del confessionale c’era l’ammonimento che gli iscritti ai partiti comunisti e socialisti erano sotto pena di esclusione dai sacramenti ma i risultati elettorali dicono quanto la presa della Chiesa in campo politico sia venuta meno abbastanza rapidamente. In fatto di separazioni e divorzi, convivenze, nascite prima del matrimonio, ecc., negli ultimi venti o trenta anni l’irrilevanza o la scarsa incidenza della predicazione è ancora più ovvia.
Può darsi che sia semplicemente un’idiosincrasia ma mi incuriosisce molto quel che mi sembra distinguere l’effetto sui gay rispetto a quello sugli etero della precettistica cattolica. La condanna della masturbazione valeva per tutti ma non aveva, credo, lo stesso effetto. Io, ma in questo non credo di essere un caso unico o raro, l’ho sempre associata allo sporco, all’indecente e l’idea, per quanto cerchi di rimuoverla, rimane. Negli etero qualcosa di simile c’è ma è accompagnata dal fatto che è quel che tutti fanno, che è normale che un etero si comporti così, purché sia accompagnata da fantasie “normali”. Per un gay, le fantasie non lo sono altrettanto e sono difficilmente confessabili. A cosa serva il sesso, per un etero è ovvio. Per un gay invece c’è sempre il bisogno di chiedersi il perché, il perché di questi desideri, e non solo perché capitano a me. Anche questa può essere un’idiosincrasia. A me, come si fanno i bambini è stato detto dai miei compagni verso i cinque o sei anni, mi ricordo, mentre giocavamo nei boschi. La cosa mi è sembrata incredibile ed insensata. Perché diavolo si doveva fare così, perché fare così facesse nascere un bambino? Credo che per un etero accettare le cose come sono, soprattutto in questo campo, sia forse più facile. Ha tutta una platea di uguali che accettano le stesse cose. Per un gay questo non è vero, deve trovare ragioni proprie. E questo rovello sulle ragioni per me non è mai finito.
Si può dire tutto sulla naturalità e sul bisogno di provare piacere ma non so se è una ragione sufficiente. Ci sono un sacco di piaceri a cui si rinuncia. Perché non a questo? Forse è questa ricerca di perché, il non accettare le cose come sono semplicemente perché sono così, che fissa noi gay su una morale che agli altri entra da un orecchio ed esce dall’altro senza aver prodotto alcun effetto. Era soprattutto la pressione sociale ed il bisogno a spingere anche i gay a sposarsi. Non sono sicuro che il non sposarsi venisse condannato come sintomo di omosessualità, credo venisse usato molto più come indicatore di incapacità o non volontà di assumersi responsabilità e quindi di scarsa affidabilità e consistenza e perciò fatto oggetto di biasimo. Purtroppo non ho frequentato osterie e bar, in cui avrei potuto sentire cosa si diceva degli altri, né mi ricordo di qualcuno ovviamente gay e non so a quali fonti uno potrebbe rifarsi per farsi un’idea fattuale in proposito. Credo che fosse rarissimo che un gay si dichiarasse ma non mi ricordo di qualcuno che venisse etichettato come tale, anche perché, prima o poi, finiva per sposarsi. L’invisibilità, anche per la Chiesa, basta. E allora il costo di sposarsi per un gay era più basso di oggi: l’unica alternativa era vivere soli.
Non sposarsi, non fare figli era un allentare i legami col resto della comunità rispetto al comporta-mento comune e questo, già di per sé, veniva visto male. Ma era soprattutto mettersi in condizioni di vita difficili, che si fosse gay o meno. Fino a quando vivevano i genitori, si poteva stare in famiglia. Dopo, si doveva provvedere da sé a tutti i lavori “domestici”, quelli che sarebbero stati fatti da una moglie, e questo poteva mettere materialmente ed economicamente in una condizione assai difficile.
BLOG PROGETTO GAY http://progettogay.myblog.it/
BLOG STORIE GAY http://nonsologay.blogspot.com/
SITO PROGETTO GAY https://sites.google.com/site/progettogay/
STORIE GAY E NON SOLO https://gayproject.wordpress.com/
BLOG STORIE GAY http://nonsologay.blogspot.com/
SITO PROGETTO GAY https://sites.google.com/site/progettogay/
STORIE GAY E NON SOLO https://gayproject.wordpress.com/
Re: VITA (GAY) DEGLI ANNI '50
Veramente un post bellissimo! Mi riporta in atmosfere di altri tempi. I vecchi sono affezionati al passato perché è una cosa loro! Grazie per questo post!
Re: VITA (GAY) DEGLI ANNI '50
Ecco la prosecuzione del post di apertura. Ringrazio ancora l'amico che me l'ha mandata, è una lettura che per me ha tanto il sapore anche della mia vita.
__________________________________
Mio padre è morto quando ero ancora bambino. Dopo qualche anno abbiamo
cambiato paese e lì non conoscevo nessuno della mia età. È stato forse il
periodo più brutto. Già prima c’era stato un po’ di distacco dai miei cugini.
Non eravamo nella stessa classe alle elementari e poi i miei avevano deciso di farmi frequentare le scuole medie (su una classe di 25 o 26, solo 2 o 3 sono andati alle medie, ovviamente nessuna bambina, e decidere di mandare avanti un figlio era una cosa su cui ci si consultava col prete. A dodici anni, qualcuno dei miei cugini lavorava già come muratore.) Essere in classi diverse, cominciare ad avere amici diversi è stata una frattura ma nulla rispetto a quella venuta dopo. Quando ci siamo trasferiti ero nel periodo della pubertà.
Non credo che fosse tanto il senso del peccato, quanto la vergogna, il non
sapermi dominare a farmi sentire un diverso ed un reietto. Io ho sempre voluto essere diverso, fin da bambino, ma non in quello o nella sessualità. Volevo pensare in maniera diversa dagli altri, essere capace di sostenere il contrario di quel che tutti credevano. Forse molti di noi non riescono ad accettare le cose come sono semplicemente perché sono così: abbiamo bisogno di spiegazioni e le cerchiamo anche dove gli altri non le trovano necessarie (o forse solo soffrivo, ma soffro tuttora, di un orgoglio luciferino, che non sono mai stato in grado di giustificare). Molto prima del sesso, questo mi aveva fatto sentire diverso, dubitare di essere accettato. A quei tempi si cominciava a mandare i figli in colonia d’estate per 3 o 4 settimane. Al rientro, avevo paura di ripresentarmi in cortile, paura di non essere più riconosciuto ed accettato.
Per i primi due anni delle medie sono andato più o meno bene ma in terza c’è stato un cambiamento dei professori e le classi sono state mischiate. È stata una tragedia. Nel primo trimestre, fioccavano i 2 e i 3 equamente distribuiti fra le varie materie. Poi mi sono un po’ ripreso.
È stato il periodo in cui mi si sono radicate le convinzioni ed i pregiudizi che poi mi sono sempre portato dietro fino ad adesso. Fin dopo i 25-26 anni, non ho mai avuto una stanza tutta per me, un ambiente che fosse mio ed esclusivamente mio, in cui nessun altro potesse mettere le mani. Mi piaceva molto leggere romanzi. Me li comperavo di nascosto con i risparmi sulla paghetta (allora, i libri della BUR costavano settanta o ottanta lire) ma finivano sempre per trovarmeli e per sequestrarmeli e non erano cose osé, mi hanno sequestrato persino l’Amleto in cui, allora, non avrei visto nulla di problematico.
Di fatto, non avevo nulla di mio e anche la paghetta settimanale era qualcosa che mi era data ma cui sapevo e sentivo di non avere diritto. Cercare di andare bene a scuola era mio dovere e tutto quello che facevo in quell’ambito era solo per il mio interesse e non meritava alcun riconoscimento ed io andavo maluccio. Mi sono accorto che questo non era il peggio. Forse riconfermava la bassa opinione che si aveva di me ma c’era anche un aspetto paradossalmente positivo in ciò. Vedere qualcuno che ce la faceva, faceva sorgere sentimenti ambivalenti: se qualcuno riusciva, questo apriva speranze anche per sé ma anche un po’ d’invidia. Se poi si sapeva che qualcuno che si era vantato di qualcosa aveva in seguito fatto fallimento nel mantenere le promesse, c’era quasi godimento, forse perché ci si racconsolava all’idea che neppure lui ce l’aveva fatta. L’idea che il successo di un giorno poteva diventare la disfatta nel giorno successivo mi ha sempre angosciato e mi ha spinto a cercare di rendere invisibili eventuali, comunque allora assenti, successi. Ma ha anche generato diffidenza per gli altri, su cosa gli altri potevano pensare, come gli altri potevano interpretare quello che facevo o dicevo, gli atteggiamenti che adottavo. E anche questo mi induceva all’invisibilità tranne i casi in cui questo non era proprio possibile.
La sensazione di non avere diritti era poi rafforzata dal fatto che non solo a scuola non andavo gran che bene ma che anche cose pratiche non ne sapevo fare. Quando ci provavo, non riuscivo mai, c’era sempre qualcosa che non andava bene o doveva essere fatta in maniera diversa e migliore. In pratica, il consiglio era che io mi astenessi persino dal provarci. Forse è stato soprattutto questo senso di incapacità che non mi faceva vedere la conquista di autonomia, il potermene andare fuori di casa, come un obiettivo realistico cui puntare. È in queste cose che la mancanza di un padre si è fatta sentire, il non avere qualcuno che fornisse una rete di sicurezza, che intervenisse, correggesse, ponesse rimedio, ma desse anche fiducia e speranza che, forse proprio anche attraverso gli errori, sarei riuscito a migliorare, che potevo farcela. E l’autonomia economica di mia madre si riduceva alla pensione di reversibilità e agli assegni famigliari.
Visti i miei scarsi risultati, è stato un vero azzardo farmi andare avanti, in un istituto tecnico. Fare il liceo avrebbe voluto dire programmare già la prosecuzione in università e, credo con ragione, si era molto scettici sulle mie possibilità. Sono andato a scuola in una città diversa da quella in cui avevo frequentato le medie, ovviamente compagni del tutto nuovi.
In prima me la cavavo anche se non provavo particolarmente attraenti le
materie che dovevo studiare. Il terzo trimestre del primo anno ho fatto due
mesi all’ospedale, ho avuto degli esami a settembre ma questo mi ha consentito di conoscere altri ragazzi del paese in cui vivevo. È stato per cercare di essere accettato da loro che ho cominciato a studiare, a voler essere bravo a scuola, all’inizio, senza grande successo. Ma è anche stato un di vita frammentata.
C’era la scuola, da una parte, e la vita a casa, nel paese, dall’altra. Erano ambienti del tutto separati, fisicamente perché gli altri studiavano in città diverse da quelle in cui c’era la mia scuola, ma anche temporalmente. Durante l’anno scolastico si studiava ed io, poi, uscivo pochissimo. Gli altri ragazzi che avevo conosciuto li vedevo la domenica mattina a messa o poco più. Era d’estate, durante le vacanze che ci frequentavamo. Andavamo a nuotare al fiume, pescavamo di frodo con le reti, giocavamo a carte a casa di qualcuno, correvamo in bicicletta. Durante l’anno scolastico, erano soprattutto la scuola e stare con i miei compagni di classe ad assorbirmi. Non sono sicuro che nei due ambienti mi vedessero alla stessa maniera.
Quando ho cominciato a pensare di essere gay non lo so, a esserne relativamente convinto credo piuttosto tardi, verso i vent’anni. Desideri omoerotici sicuramente li ho avuti presto ma non sono sicuro che fosse soprattutto il sesso quello che cercavo. Era il mettersi nudo di fronte a un altro che si metteva nudo davanti a me, non avere più paura del giudizio altrui, l’idea di essere accettato totalmente senza avere nulla da nascondere e di poter conoscere tutto di un altro. (Riuscire a sapere cosa passava per la mente di un altro, i suoi desideri più nascosti, era una delle cose che avrei voluto di più e il non riuscirci, l’avere sempre davanti dei misteri imperscrutabili una delle mie angosce.)
Ma non potevo avere niente di tutto questo. Sia pure confusamente, anche non volendolo ammettere, sapevo che per me quelle cose avrebbero avuto un significato diverso che per gli altri e il fatto che lo dovessi nascondere, che dovessi apparire più innocente di quanto non fossi, di mentire avrebbe annullato tutto. Anche nudi gli uni di fronte agli altri, non avrei mai confessato il mio segreto, sarei stato sleale. Inoltre, non avendo confidenza con loro, volevo comunque pensare che vivessero una vita pura, certo più pura della mia. La sensazione di essere l’unico “sporco” mi ha rinchiuso ed isolato ancora di più. È certo stato anche per compensare questo senso di inferiorità che ho sempre avuto bisogno di dare agli altri motivi per accettarmi, che ho cercato di sembrare intelligente, per quel che mi era possibile.
Gli altri sospettavano la mia omosessualità? Non so. Ma almeno uno di loro, che credo mi stimasse e mi fosse abbastanza amico, mi disse che pensava che io lo fossi ed io glissai: ancora non ne ero convinto o per lo meno non lo accettavo neppure io.
Non era chiaro che anche terminando l’istituto tecnico avrei trovato un lavoro e anche se l’avessi trovato non mi sentivo in grado di vivere da solo, con mia madre, e credo che neppure lei credesse in questa possibilità, per quanto vivere in quella situazione, con meno autonomia di quanta avessi io, le dovesse pesare moltissimo.
Buttarmi sullo studio è stata un’evasione? Entro certi limiti sì. Quello che studiavo mi piaceva e mi piaceva studiare, ma sapevo benissimo a cosa rinunciavo non andando la sera al bar o al cinema. Di soldi ce n’erano comunque pochi e soprattutto non erano gli ambienti in cui avrei voluto parlare con i pochi della mia età che frequentavo, soprattutto se volevo sostenere opinioni minoritarie (non sul sesso, beninteso, per quello mi mancava il coraggio).
Erano molto meglio i lunghi pomeriggi estivi a nuotare sulla riva del fiume. Lì, c’erano solo quelli che continuavano a studiare, i ragazzi e forse una o due ragazze. Solo il sabato e la domenica e pochi giorni d’agosto, perché allora le ferie erano molto brevi, si affollavano di gente che usava il fiume anche per lavarsi.
Come dice Project, la scuola di un tempo era tutt’altro da quella che appare dai post che ho letto. Già per frequentare le medie e ancor più le superiori, bisognava andare nelle città vicine, quindi stare fuori di casa per buona parte del giorno. Anche qui, i genitori dovevano darti libertà e neppure potevano più di tanto controllare quanto e se uno studiasse, se non dai voti in pagella. Non mi ricordo fenomeni di bullismo feroce ma può darsi che questo dipenda dal fatto che non ricordo di esserne stato oggetto io.
Ovviamente c’erano battute sui gay ma non mi sembravano particolarmente cattive. Non mi ricordo che qualcuno fosse stato marchiato come tale. Del resto, nessuno avrebbe mai ammesso di esserlo. La scuola era diversa rispetto ad oggi perché erano diversi gli studenti. In un istituto tecnico le famiglie di provenienza erano di impiegati, piccoli, anzi piccolissimi imprenditori, commercianti e operai. Quello cui ci si preparava era un lavoro da impiegati. Per i ragazzi era praticamente d’obbligo indossare giacca e cravatta (ma già portare i pantaloni lunghi faceva sentire grandi, fino alle medie, si andava con i pantaloni corti); per le ragazze c’era il tacito divieto, sempre rispettato, di usare rossetto o smalto sulle unghie. Nei licei, le cose devono essere state un po’ diverse ma non credo poi molto.
Si dava per implicito che l’istruzione e un po’ di cultura fossero importanti. Era il passaporto necessario per entrare in un certo tipo di ambiente, per molte famiglie, per far fare ai figli un salto di classe sociale, per dar loro una vita più agiata e in quel periodo la scuola effettivamente permetteva tutto questo. Era una scuola piuttosto selettiva. Si partiva il primo anno con 5 classi ciascuna con una trentina di studenti e si arrivava in quinta con 3 classi di 20-25.
Qual era l’idea di omosessualità che circolava? Posso solo parlare della mia, perché, a parte qualche battuta, di queste cose non si parlava, o almeno io non parlavo. Si leggeva in seconda media l’Iliade, ma non mi ricordo che ci fossero allusioni alla purezza dell’amicizia tra Achille e Patroclo. Il primo anno delle superiori si leggeva l’Eneide ma Eurialo e Niso passavano inosservati. Solo verso la fine delle superiori ho letto Agostino di Moravia, un po’ di Pasolini, un romanzo credo di Palazzeschi di cui non ricordo il titolo (mi viene Rio Bo, ma mi sembra impossibile) o forse di Bontempelli, con due ragazzi che si amano, un racconto di Sartre, ne Il muro, mi pare, c’è un gay in un romanzo di Pratolini. Anche al cinema c’era poco: una macchietta nella Dolce vita, un accenno non edificante nel Visconti di Rocco e i suoi fratelli. Basandomi su così poco, anche se cominciavo a pensare di poter essere gay, cosa questo volesse dire era molto nebuloso. Mi era del tutto estranea l’idea di potermi innamorare anche se avevo degli amici con cui, se avessi potuto, avrei passato tutto il tempo possibile e sapere che loro si erano visti e non me l’avevano detto, sentirmi escluso, mi dava un dolore incredibile. L’idea di vivere assieme a un altro, possibilmente tutta una vita, di formare una famiglia, era assolutamente fuori dai miei orizzonti. Per molti aspetti, questo era vero anche per gli etero. A quell’età si potevano avere cottarelle, in genere per le compagne di classe, ma da tenere segrete, da non rivelare, al massimo da far timidamente trasparire all’interessata fermandosi però lì. Rendere in qualche modo pubblico e ufficiale un simile sentimento era cosa del tutto fuori dal comune. Certo loro avevano l’idea che prima o poi si sarebbero sposati, ma prima o poi, in anni a venire.
Il problema comune era che staccarsi dalla famiglia, non godere più di tutti i servizi che questa forniva, staccarsi dai genitori, rendersi autonomi economicamente ed emotivamente, assumersi tutte le responsabilità che vivere da soli avrebbe comportato era qualcosa che, prima di aver trovato un lavoro, neppure passava per la testa.
Rivelare di avere una fidanzata a quell’età suscitava tutta la riprovazione della famiglia, ancora estremamente attaccata alla pratica di quella virtù cardinale che è la prudenza, per non parlare dell’opinione che si sarebbe fatta sull’onestà della fanciulla. Se invece di una fidanzata si trattava di un fidanzato, il tutto diventava inimmaginabile. Non credo poi che esistessero esempi di due uomini non parenti stretti che vivessero assieme; la cosa era forse più accettata per due donne, se rimaste sole, specie se un po’ in là con gli anni.
Di fatto anche i single erano molto rari, per ovvie ragioni economiche. Vivere da single costa più di quanto costa pro-capite vivere in famiglia. Diventa possibile solo quando il reddito pro-capite è sufficientemente alto. Sono diventati più comuni negli anni ’80, quando era aumentata l’occupazione a livello impiegatizio e dirigenziale. Vivere in famiglia per un gay richiede però spesso rendere invisibile la propria omosessualità, per la paura di un possibile o probabile rifiuto, renderla invisibile non solo in famiglia ma anche fuori di essa. L’invisibilità è forse anche una delle ragioni per cui, pur essendo allora il pregiudizio omofobo forte tanto quanto lo è oggi, esso non si esprimeva in pubblico con la stessa forza con cui si esprime oggi: veniva a mancare l’occasione per disprezzare. E può essere anche una delle ragioni per cui non si sentiva la necessità di introdurre norme legislative in materia. Alcune erano necessarie. Fino agli anni ’90 era facile trovare pedopornografia nelle edicole. Ma non sono sicuro che ci si sia limitati a questi casi. La pornografia è scomparsa dalle edicole, anche per i cambiamenti tecnologici che ci sono stati. Ma l’atteggiamento della gente verso di essa, se non la normativa, è cambiato: mentre quella etero è comunque diffusa e accettata, il pregiudizio ed il rifiuto esplicito, l’ostracismo per quella omosessuale è aumentato e si ritrova solo nei porno-shop.
Io continuavo ad avere desideri omosessuali ma non il desiderio di una vita gay. Avrei voluto anche un po’ di sesso ma di tanto in tanto, ciascuno vivendo la propria vita. Tra i miei compagni di scuola ce n’era uno cui mi sentivo molto legato. Non era solo la sua intelligenza e la sua bellezza che mi attiravano, era più la sua sicurezza, lo scoprire che avevamo idee comuni su molte cose, che ci piacevano e ci davano le stesse emozioni gli stessi libri e gli stessi film. Con lui, pur non vedendoci più se non un paio di volte in 7 o 8 anni dopo la maturità, siamo rimasti amici e ci scrivevamo spesso. L’amicizia si è interrotta per colpa mia, quando gli ho detto, per lettera, che forse il mio sentimento per lui aveva anche altre motivazioni.
Sono sicuro di aver usato un modo di esprimermi sbagliato. Devo averlo messo in una situazione difficile e imbarazzante, forse averlo deluso, forse indotto a sentirsi tradito ed ingannato. Smise di scrivermi. Un paio d’anni dopo mi mandò l’annuncio di nozze.
Verso il ’63 cominciavano i primi scioperi degli operai nelle fabbriche e anche degli studenti nelle scuole, non credo dei professori. Di politica però non mi ricordo che si discutesse molto tra di noi; non c’era nessuno che io conoscessi che fosse impegnato in un partito. Io ero strettamente controllato e precettato ad entrare in classe anche durante gli scioperi. Le poche volte che non l’ho fatto, mi ricordo di una noia e stanchezza infinita, in giornate autunnali grigie e fredde. Allora gli studenti non facevano cortei e si passava il tempo bighellonando in giro per la città.
Dai miei compagni ho avuto moltissimo, la loro amicizia, entro i limiti che forse soprattutto io ponevo, ma anche l’aiuto a scoprire cose, dall’imparare a giocare a biliardo, ai libri da leggere, possibilmente con qualche pagina osé, alla dimostrazione di un teorema. Credo che gran parte dei miei interessi e di quello che ho imparato nei miei studi, università compresa, lo debba a loro. I libri di testo erano fortunatamente molto più corti di quelli ora in uso ma ho anche avuto dei professori di una bravura incredibile (con eccezioni com’è naturale ed inevitabile). Alle superiori, credo che mi ritenessero intelligente ma strano. Il professore di lettere, ad esempio, giudicava i miei ragionamenti inutilmente involuti e contorti, censurava il fatto che non prendessi mai la via più diretta ed ovvia per arrivare alla conclusione. La cosa deve averlo colpito così tanto che parlò di me anche in altre classi. Il risultato fu che un pomeriggio, uscendo da scuola, una ragazza mi fermò per regalarmi una scatola di fiammiferi controvento. Non ho mai capito il recondito significato del messaggio, se c’era, ma ritrovai anni dopo quella ragazza in università ed è stato un incontro molto importante per me. Negli ultimi anni e soprattutto agli esami di maturità andai piuttosto bene. Ero il terzo o quarto della scuola e potevo avere presalario ed esenzione dalle tasse. Feci un paio di colloqui di lavoro ma alla fine si decise di farmi tentare con l’università. La scelta della facoltà non era un problema perché chi veniva dagli istituti tecnici aveva pochissime alternative ma credo che, anche se non vi fossi stato costretto, avrei scelto quella che ho frequentato.
__________________________________
Mio padre è morto quando ero ancora bambino. Dopo qualche anno abbiamo
cambiato paese e lì non conoscevo nessuno della mia età. È stato forse il
periodo più brutto. Già prima c’era stato un po’ di distacco dai miei cugini.
Non eravamo nella stessa classe alle elementari e poi i miei avevano deciso di farmi frequentare le scuole medie (su una classe di 25 o 26, solo 2 o 3 sono andati alle medie, ovviamente nessuna bambina, e decidere di mandare avanti un figlio era una cosa su cui ci si consultava col prete. A dodici anni, qualcuno dei miei cugini lavorava già come muratore.) Essere in classi diverse, cominciare ad avere amici diversi è stata una frattura ma nulla rispetto a quella venuta dopo. Quando ci siamo trasferiti ero nel periodo della pubertà.
Non credo che fosse tanto il senso del peccato, quanto la vergogna, il non
sapermi dominare a farmi sentire un diverso ed un reietto. Io ho sempre voluto essere diverso, fin da bambino, ma non in quello o nella sessualità. Volevo pensare in maniera diversa dagli altri, essere capace di sostenere il contrario di quel che tutti credevano. Forse molti di noi non riescono ad accettare le cose come sono semplicemente perché sono così: abbiamo bisogno di spiegazioni e le cerchiamo anche dove gli altri non le trovano necessarie (o forse solo soffrivo, ma soffro tuttora, di un orgoglio luciferino, che non sono mai stato in grado di giustificare). Molto prima del sesso, questo mi aveva fatto sentire diverso, dubitare di essere accettato. A quei tempi si cominciava a mandare i figli in colonia d’estate per 3 o 4 settimane. Al rientro, avevo paura di ripresentarmi in cortile, paura di non essere più riconosciuto ed accettato.
Per i primi due anni delle medie sono andato più o meno bene ma in terza c’è stato un cambiamento dei professori e le classi sono state mischiate. È stata una tragedia. Nel primo trimestre, fioccavano i 2 e i 3 equamente distribuiti fra le varie materie. Poi mi sono un po’ ripreso.
È stato il periodo in cui mi si sono radicate le convinzioni ed i pregiudizi che poi mi sono sempre portato dietro fino ad adesso. Fin dopo i 25-26 anni, non ho mai avuto una stanza tutta per me, un ambiente che fosse mio ed esclusivamente mio, in cui nessun altro potesse mettere le mani. Mi piaceva molto leggere romanzi. Me li comperavo di nascosto con i risparmi sulla paghetta (allora, i libri della BUR costavano settanta o ottanta lire) ma finivano sempre per trovarmeli e per sequestrarmeli e non erano cose osé, mi hanno sequestrato persino l’Amleto in cui, allora, non avrei visto nulla di problematico.
Di fatto, non avevo nulla di mio e anche la paghetta settimanale era qualcosa che mi era data ma cui sapevo e sentivo di non avere diritto. Cercare di andare bene a scuola era mio dovere e tutto quello che facevo in quell’ambito era solo per il mio interesse e non meritava alcun riconoscimento ed io andavo maluccio. Mi sono accorto che questo non era il peggio. Forse riconfermava la bassa opinione che si aveva di me ma c’era anche un aspetto paradossalmente positivo in ciò. Vedere qualcuno che ce la faceva, faceva sorgere sentimenti ambivalenti: se qualcuno riusciva, questo apriva speranze anche per sé ma anche un po’ d’invidia. Se poi si sapeva che qualcuno che si era vantato di qualcosa aveva in seguito fatto fallimento nel mantenere le promesse, c’era quasi godimento, forse perché ci si racconsolava all’idea che neppure lui ce l’aveva fatta. L’idea che il successo di un giorno poteva diventare la disfatta nel giorno successivo mi ha sempre angosciato e mi ha spinto a cercare di rendere invisibili eventuali, comunque allora assenti, successi. Ma ha anche generato diffidenza per gli altri, su cosa gli altri potevano pensare, come gli altri potevano interpretare quello che facevo o dicevo, gli atteggiamenti che adottavo. E anche questo mi induceva all’invisibilità tranne i casi in cui questo non era proprio possibile.
La sensazione di non avere diritti era poi rafforzata dal fatto che non solo a scuola non andavo gran che bene ma che anche cose pratiche non ne sapevo fare. Quando ci provavo, non riuscivo mai, c’era sempre qualcosa che non andava bene o doveva essere fatta in maniera diversa e migliore. In pratica, il consiglio era che io mi astenessi persino dal provarci. Forse è stato soprattutto questo senso di incapacità che non mi faceva vedere la conquista di autonomia, il potermene andare fuori di casa, come un obiettivo realistico cui puntare. È in queste cose che la mancanza di un padre si è fatta sentire, il non avere qualcuno che fornisse una rete di sicurezza, che intervenisse, correggesse, ponesse rimedio, ma desse anche fiducia e speranza che, forse proprio anche attraverso gli errori, sarei riuscito a migliorare, che potevo farcela. E l’autonomia economica di mia madre si riduceva alla pensione di reversibilità e agli assegni famigliari.
Visti i miei scarsi risultati, è stato un vero azzardo farmi andare avanti, in un istituto tecnico. Fare il liceo avrebbe voluto dire programmare già la prosecuzione in università e, credo con ragione, si era molto scettici sulle mie possibilità. Sono andato a scuola in una città diversa da quella in cui avevo frequentato le medie, ovviamente compagni del tutto nuovi.
In prima me la cavavo anche se non provavo particolarmente attraenti le
materie che dovevo studiare. Il terzo trimestre del primo anno ho fatto due
mesi all’ospedale, ho avuto degli esami a settembre ma questo mi ha consentito di conoscere altri ragazzi del paese in cui vivevo. È stato per cercare di essere accettato da loro che ho cominciato a studiare, a voler essere bravo a scuola, all’inizio, senza grande successo. Ma è anche stato un di vita frammentata.
C’era la scuola, da una parte, e la vita a casa, nel paese, dall’altra. Erano ambienti del tutto separati, fisicamente perché gli altri studiavano in città diverse da quelle in cui c’era la mia scuola, ma anche temporalmente. Durante l’anno scolastico si studiava ed io, poi, uscivo pochissimo. Gli altri ragazzi che avevo conosciuto li vedevo la domenica mattina a messa o poco più. Era d’estate, durante le vacanze che ci frequentavamo. Andavamo a nuotare al fiume, pescavamo di frodo con le reti, giocavamo a carte a casa di qualcuno, correvamo in bicicletta. Durante l’anno scolastico, erano soprattutto la scuola e stare con i miei compagni di classe ad assorbirmi. Non sono sicuro che nei due ambienti mi vedessero alla stessa maniera.
Quando ho cominciato a pensare di essere gay non lo so, a esserne relativamente convinto credo piuttosto tardi, verso i vent’anni. Desideri omoerotici sicuramente li ho avuti presto ma non sono sicuro che fosse soprattutto il sesso quello che cercavo. Era il mettersi nudo di fronte a un altro che si metteva nudo davanti a me, non avere più paura del giudizio altrui, l’idea di essere accettato totalmente senza avere nulla da nascondere e di poter conoscere tutto di un altro. (Riuscire a sapere cosa passava per la mente di un altro, i suoi desideri più nascosti, era una delle cose che avrei voluto di più e il non riuscirci, l’avere sempre davanti dei misteri imperscrutabili una delle mie angosce.)
Ma non potevo avere niente di tutto questo. Sia pure confusamente, anche non volendolo ammettere, sapevo che per me quelle cose avrebbero avuto un significato diverso che per gli altri e il fatto che lo dovessi nascondere, che dovessi apparire più innocente di quanto non fossi, di mentire avrebbe annullato tutto. Anche nudi gli uni di fronte agli altri, non avrei mai confessato il mio segreto, sarei stato sleale. Inoltre, non avendo confidenza con loro, volevo comunque pensare che vivessero una vita pura, certo più pura della mia. La sensazione di essere l’unico “sporco” mi ha rinchiuso ed isolato ancora di più. È certo stato anche per compensare questo senso di inferiorità che ho sempre avuto bisogno di dare agli altri motivi per accettarmi, che ho cercato di sembrare intelligente, per quel che mi era possibile.
Gli altri sospettavano la mia omosessualità? Non so. Ma almeno uno di loro, che credo mi stimasse e mi fosse abbastanza amico, mi disse che pensava che io lo fossi ed io glissai: ancora non ne ero convinto o per lo meno non lo accettavo neppure io.
Non era chiaro che anche terminando l’istituto tecnico avrei trovato un lavoro e anche se l’avessi trovato non mi sentivo in grado di vivere da solo, con mia madre, e credo che neppure lei credesse in questa possibilità, per quanto vivere in quella situazione, con meno autonomia di quanta avessi io, le dovesse pesare moltissimo.
Buttarmi sullo studio è stata un’evasione? Entro certi limiti sì. Quello che studiavo mi piaceva e mi piaceva studiare, ma sapevo benissimo a cosa rinunciavo non andando la sera al bar o al cinema. Di soldi ce n’erano comunque pochi e soprattutto non erano gli ambienti in cui avrei voluto parlare con i pochi della mia età che frequentavo, soprattutto se volevo sostenere opinioni minoritarie (non sul sesso, beninteso, per quello mi mancava il coraggio).
Erano molto meglio i lunghi pomeriggi estivi a nuotare sulla riva del fiume. Lì, c’erano solo quelli che continuavano a studiare, i ragazzi e forse una o due ragazze. Solo il sabato e la domenica e pochi giorni d’agosto, perché allora le ferie erano molto brevi, si affollavano di gente che usava il fiume anche per lavarsi.
Come dice Project, la scuola di un tempo era tutt’altro da quella che appare dai post che ho letto. Già per frequentare le medie e ancor più le superiori, bisognava andare nelle città vicine, quindi stare fuori di casa per buona parte del giorno. Anche qui, i genitori dovevano darti libertà e neppure potevano più di tanto controllare quanto e se uno studiasse, se non dai voti in pagella. Non mi ricordo fenomeni di bullismo feroce ma può darsi che questo dipenda dal fatto che non ricordo di esserne stato oggetto io.
Ovviamente c’erano battute sui gay ma non mi sembravano particolarmente cattive. Non mi ricordo che qualcuno fosse stato marchiato come tale. Del resto, nessuno avrebbe mai ammesso di esserlo. La scuola era diversa rispetto ad oggi perché erano diversi gli studenti. In un istituto tecnico le famiglie di provenienza erano di impiegati, piccoli, anzi piccolissimi imprenditori, commercianti e operai. Quello cui ci si preparava era un lavoro da impiegati. Per i ragazzi era praticamente d’obbligo indossare giacca e cravatta (ma già portare i pantaloni lunghi faceva sentire grandi, fino alle medie, si andava con i pantaloni corti); per le ragazze c’era il tacito divieto, sempre rispettato, di usare rossetto o smalto sulle unghie. Nei licei, le cose devono essere state un po’ diverse ma non credo poi molto.
Si dava per implicito che l’istruzione e un po’ di cultura fossero importanti. Era il passaporto necessario per entrare in un certo tipo di ambiente, per molte famiglie, per far fare ai figli un salto di classe sociale, per dar loro una vita più agiata e in quel periodo la scuola effettivamente permetteva tutto questo. Era una scuola piuttosto selettiva. Si partiva il primo anno con 5 classi ciascuna con una trentina di studenti e si arrivava in quinta con 3 classi di 20-25.
Qual era l’idea di omosessualità che circolava? Posso solo parlare della mia, perché, a parte qualche battuta, di queste cose non si parlava, o almeno io non parlavo. Si leggeva in seconda media l’Iliade, ma non mi ricordo che ci fossero allusioni alla purezza dell’amicizia tra Achille e Patroclo. Il primo anno delle superiori si leggeva l’Eneide ma Eurialo e Niso passavano inosservati. Solo verso la fine delle superiori ho letto Agostino di Moravia, un po’ di Pasolini, un romanzo credo di Palazzeschi di cui non ricordo il titolo (mi viene Rio Bo, ma mi sembra impossibile) o forse di Bontempelli, con due ragazzi che si amano, un racconto di Sartre, ne Il muro, mi pare, c’è un gay in un romanzo di Pratolini. Anche al cinema c’era poco: una macchietta nella Dolce vita, un accenno non edificante nel Visconti di Rocco e i suoi fratelli. Basandomi su così poco, anche se cominciavo a pensare di poter essere gay, cosa questo volesse dire era molto nebuloso. Mi era del tutto estranea l’idea di potermi innamorare anche se avevo degli amici con cui, se avessi potuto, avrei passato tutto il tempo possibile e sapere che loro si erano visti e non me l’avevano detto, sentirmi escluso, mi dava un dolore incredibile. L’idea di vivere assieme a un altro, possibilmente tutta una vita, di formare una famiglia, era assolutamente fuori dai miei orizzonti. Per molti aspetti, questo era vero anche per gli etero. A quell’età si potevano avere cottarelle, in genere per le compagne di classe, ma da tenere segrete, da non rivelare, al massimo da far timidamente trasparire all’interessata fermandosi però lì. Rendere in qualche modo pubblico e ufficiale un simile sentimento era cosa del tutto fuori dal comune. Certo loro avevano l’idea che prima o poi si sarebbero sposati, ma prima o poi, in anni a venire.
Il problema comune era che staccarsi dalla famiglia, non godere più di tutti i servizi che questa forniva, staccarsi dai genitori, rendersi autonomi economicamente ed emotivamente, assumersi tutte le responsabilità che vivere da soli avrebbe comportato era qualcosa che, prima di aver trovato un lavoro, neppure passava per la testa.
Rivelare di avere una fidanzata a quell’età suscitava tutta la riprovazione della famiglia, ancora estremamente attaccata alla pratica di quella virtù cardinale che è la prudenza, per non parlare dell’opinione che si sarebbe fatta sull’onestà della fanciulla. Se invece di una fidanzata si trattava di un fidanzato, il tutto diventava inimmaginabile. Non credo poi che esistessero esempi di due uomini non parenti stretti che vivessero assieme; la cosa era forse più accettata per due donne, se rimaste sole, specie se un po’ in là con gli anni.
Di fatto anche i single erano molto rari, per ovvie ragioni economiche. Vivere da single costa più di quanto costa pro-capite vivere in famiglia. Diventa possibile solo quando il reddito pro-capite è sufficientemente alto. Sono diventati più comuni negli anni ’80, quando era aumentata l’occupazione a livello impiegatizio e dirigenziale. Vivere in famiglia per un gay richiede però spesso rendere invisibile la propria omosessualità, per la paura di un possibile o probabile rifiuto, renderla invisibile non solo in famiglia ma anche fuori di essa. L’invisibilità è forse anche una delle ragioni per cui, pur essendo allora il pregiudizio omofobo forte tanto quanto lo è oggi, esso non si esprimeva in pubblico con la stessa forza con cui si esprime oggi: veniva a mancare l’occasione per disprezzare. E può essere anche una delle ragioni per cui non si sentiva la necessità di introdurre norme legislative in materia. Alcune erano necessarie. Fino agli anni ’90 era facile trovare pedopornografia nelle edicole. Ma non sono sicuro che ci si sia limitati a questi casi. La pornografia è scomparsa dalle edicole, anche per i cambiamenti tecnologici che ci sono stati. Ma l’atteggiamento della gente verso di essa, se non la normativa, è cambiato: mentre quella etero è comunque diffusa e accettata, il pregiudizio ed il rifiuto esplicito, l’ostracismo per quella omosessuale è aumentato e si ritrova solo nei porno-shop.
Io continuavo ad avere desideri omosessuali ma non il desiderio di una vita gay. Avrei voluto anche un po’ di sesso ma di tanto in tanto, ciascuno vivendo la propria vita. Tra i miei compagni di scuola ce n’era uno cui mi sentivo molto legato. Non era solo la sua intelligenza e la sua bellezza che mi attiravano, era più la sua sicurezza, lo scoprire che avevamo idee comuni su molte cose, che ci piacevano e ci davano le stesse emozioni gli stessi libri e gli stessi film. Con lui, pur non vedendoci più se non un paio di volte in 7 o 8 anni dopo la maturità, siamo rimasti amici e ci scrivevamo spesso. L’amicizia si è interrotta per colpa mia, quando gli ho detto, per lettera, che forse il mio sentimento per lui aveva anche altre motivazioni.
Sono sicuro di aver usato un modo di esprimermi sbagliato. Devo averlo messo in una situazione difficile e imbarazzante, forse averlo deluso, forse indotto a sentirsi tradito ed ingannato. Smise di scrivermi. Un paio d’anni dopo mi mandò l’annuncio di nozze.
Verso il ’63 cominciavano i primi scioperi degli operai nelle fabbriche e anche degli studenti nelle scuole, non credo dei professori. Di politica però non mi ricordo che si discutesse molto tra di noi; non c’era nessuno che io conoscessi che fosse impegnato in un partito. Io ero strettamente controllato e precettato ad entrare in classe anche durante gli scioperi. Le poche volte che non l’ho fatto, mi ricordo di una noia e stanchezza infinita, in giornate autunnali grigie e fredde. Allora gli studenti non facevano cortei e si passava il tempo bighellonando in giro per la città.
Dai miei compagni ho avuto moltissimo, la loro amicizia, entro i limiti che forse soprattutto io ponevo, ma anche l’aiuto a scoprire cose, dall’imparare a giocare a biliardo, ai libri da leggere, possibilmente con qualche pagina osé, alla dimostrazione di un teorema. Credo che gran parte dei miei interessi e di quello che ho imparato nei miei studi, università compresa, lo debba a loro. I libri di testo erano fortunatamente molto più corti di quelli ora in uso ma ho anche avuto dei professori di una bravura incredibile (con eccezioni com’è naturale ed inevitabile). Alle superiori, credo che mi ritenessero intelligente ma strano. Il professore di lettere, ad esempio, giudicava i miei ragionamenti inutilmente involuti e contorti, censurava il fatto che non prendessi mai la via più diretta ed ovvia per arrivare alla conclusione. La cosa deve averlo colpito così tanto che parlò di me anche in altre classi. Il risultato fu che un pomeriggio, uscendo da scuola, una ragazza mi fermò per regalarmi una scatola di fiammiferi controvento. Non ho mai capito il recondito significato del messaggio, se c’era, ma ritrovai anni dopo quella ragazza in università ed è stato un incontro molto importante per me. Negli ultimi anni e soprattutto agli esami di maturità andai piuttosto bene. Ero il terzo o quarto della scuola e potevo avere presalario ed esenzione dalle tasse. Feci un paio di colloqui di lavoro ma alla fine si decise di farmi tentare con l’università. La scelta della facoltà non era un problema perché chi veniva dagli istituti tecnici aveva pochissime alternative ma credo che, anche se non vi fossi stato costretto, avrei scelto quella che ho frequentato.
- progettogayforum
- Amministratore
- Messaggi: 5980
- Iscritto il: sabato 9 maggio 2009, 22:05
Re: VITA (GAY) DEGLI ANNI '50
Ecco l'ulteriore prosecuzione della biografia contenuta nei post precedenti. ringrazio moltissimo l'utente che le l'ha inviata!
___________________
Non ho avuto problemi né nella scelta dell’università né in quella della facoltà perché le alternative erano poche. Nella mia regione allora c’erano quattro università e da questo punto di vista era molto ricca: ce n’erano molte che non ne avevano neanche una. Adesso, qui, credo che siano una decina e il numero di facoltà e corsi di laurea è esploso.
Certamente mi lascio prendere dalla nostalgia ma credo che il vecchio assetto avesse dei vantaggi, molto costosi, che sono andati irrimediabilmente, ma per altri versi fortunatamente, persi. Tranne che per i pochi che venivano da famiglie in cui i genitori erano professionisti, iscriversi all’università voleva dire staccarsi dalla famiglia, talvolta anche materialmente, ma soprattutto psicologicamente. In un paese di sette o ottomila abitanti, nel mio anno credo che lo facessimo in due o tre, in tutto, gli universitari saranno stati una decina: iscriversi era entrare in un’élite molto limitata e staccata dalla vita del resto della comunità.
Andare all’università costava, in tasse, libri e trasporti, quando si poteva fare il pendolare, o affitto di stanze altrimenti, ma soprattutto in mancati redditi (un ragioniere, un perito o un geometra non avevano problemi a trovare un lavoro ed uno stipendio adeguato). Era una scelta che si sapeva rischiosa e che avrebbe eventualmente dato frutti solo dopo quattro, di solito cinque o sei anni. Questo incideva sull’ottica che gli studenti avevano: lo studio era visto come un privilegio e diventava il più importante impegno, qualcosa che assorbiva a tempo pieno, che non poteva essere sacrificato ad altro. Si garantiva agli studenti autonomia ma anche responsabilità. Laurearsi possibilmente bene e presto era l’obiettivo di tutta la famiglia che faceva il possibile per mettere nelle condizioni di raggiungere l’obiettivo ma questo decideva anche quale fosse il dovere dello studente e il comportamento da tenere: lamentarsi della sfortuna o del professore carogna non era accettato facilmente da gente che lavorava in fabbrica, e nelle fabbriche di allora con sindacati molto più deboli, o nei campi.
Inoltre, l’aumento di coloro che si iscrivono all’università è certamente un segno positivo ma indica anche il fatto che diventa una scelta molto meno libera e impegnativa di un tempo. Oggi si è in pratica obbligati a diplomarsi e la pressione della famiglia e dei pari per iscriversi all’università è molto forte, soprattutto se non si trova subito un lavoro.
L’uso che si faceva del tempo era interamente responsabilità propria ed era sentita come tale. E anche il tempo era diverso: gli usi che se ne potevano fare erano molto più limitati. Non c’erano telefonini e anche le case con telefono erano poche. Relativamente pochi avevano un’auto in famiglia e la patente. La televisione si è diffusa soprattutto negli anni ’60 e offriva spazi limitati: c’erano solo due canali e solo in alcune regioni si poteva vedere la Svizzera, non c’erano trasmissioni il mattino e la sera per le undici era finito tutto. Non c’erano l’happy hour e i pub, neppure Burghy e sushi bar, al massimo osterie.
Durante la settimana non c’erano discoteche e anche il sabato e la domenica, c’erano le balere senza disk jockey. Non c’erano cd, mp3 e altre diavolerie. C’era molto più tempo per leggere e pensare in solitudine senza dover rinunciare ad altro.
Nella mia università, almeno un 30% degli iscritti veniva da altre regioni e finiva per viverci tutto il giorno. Averla sotto casa ha abbattuto i costi che si devono sostenere, ha permesso a molti che altrimenti sarebbero stati esclusi per motivi economici di frequentarla. Ma ha avuto anche aspetti negativi. Molte delle nuove università sono partite senza strutture materiali (edifici, biblioteche, mense, ecc.) adeguate e senza una tradizione alle spalle. Il corpo docente era spesso pendolare e quindi non sempre presente e sempre di corsa, non sempre era scelto in maniera accurata, solitamente non vedeva la sede in cui insegnava come la propria meta finale ma più un ripiego in attesa di raggiungere sedi più prestigiose.
Col tempo alcuni di questi difetti sono stati almeno in parte corretti ma molto era ormai perso per sempre. L’università di allora era aperta e gli studenti ci restavano fino a tardi la sera. Accanto ai corsi, c’erano cicli di film, qualche concerto, cori, ecc., che credo siano scomparsi. Averla vicino a casa ha finito per rendere la casa più attraente dell’università e lo studio solo uno tra i molti impegni. Paradossalmente, molto più oggi di allora, si sente dire di conti su quante ore di lezione giustifichino l’andarci, che è la morte dell’esperienza universitaria e così finiamo per esaltare l’Erasmus.
Anche per quanto riguarda la scelta della facoltà, per chi veniva dagli istituti tecnici, c’erano, credo abbastanza giustamente, anche se forse esagerando, poche alternative, per chi veniva dalle magistrali c’era solo Magistero. Nel mio caso, poi, la decisione è stata largamente determinata da banali problemi logistici. Le mie preferenze andavano ad un’altra università, dove c’era un professore molto noto e che scriveva di cose un po’ astruse ma che mi sembravano interessanti. Venendo da un istituto tecnico, ho sempre aspirato alla “alta cultura”, a quella raffinata ed eterea che a me era mancata e manca.
Di quella in cui ho finito per iscrivermi, nessuno dei docenti era particolarmente noto. Credo che, seguendo le mie preferenze, avrei fatto una scelta sbagliata. Il professore che mi interessava era alla fine della sua carriera e credo avesse già dato tutto quello che aveva da dare. Ho anche provato a leggere alcuni dei suoi libri e li ho trovati certamente bizzarri ma assolutamente incomprensibili ed indigeribili. In quella in cui sono andato, nelle discipline che mi interessavano di più, insegnavano docenti giovani, all’inizio della loro carriera, appena ritornati da studi all’estero, chi in Inghilterra, chi in Francia, chi negli Stati Uniti, e pieni di entusiasmo. Credo di essere stato fortunato nel poter evitare le lezioni del “grande vecchio” locale.
Si parla molto di internazionalizzazione, di imitare le università straniere nell’organizzazione dei corsi, nei programmi, nell’insegnamento in inglese (ignorando il deprecabile livello di conoscenza linguistica di gran parte di chi dovrebbe farlo). Quando la nostra università era “chiusa”, almeno per quel che riguarda la mia esperienza, era molto più aperta al clima internazionale di oggi: quando ho poi seguito corsi di specializzazione all’estero, mi sono reso conto che molti dei libri in uso per i master fuori io li conoscevo già, e molti dei nostri testi erano assolutamente dello stesso livello. Non ho visto un mondo nuovo come è capitato a generazioni anche di poco successive. Io ho frequentato l’università da pendolare, continuando ad abitare a casa e facendomi due ore, quando andava bene, di treno il giorno, per altro molto produttive. Allora riuscivo ad isolarmi e studiare anche in vetture molto affollate e gelide o infuocate e ho letto e imparato moltissimo in quelle ore.
Formalmente, la frequenza era obbligatoria ma non c’erano veri controlli. Io però, fin dall’inizio, ho sempre frequentato. In pratica andavo in università dal lunedì al sabato, perché allora si facevano lezioni anche il sabato, dalle 8,30 del mattino alle 18,30 della sera, il sabato solo fino alle 13,30.
Quasi da subito, si è formato un gruppetto. Abbiamo presto fraternizzato e, con qualche scomparsa negli anni, siamo rimasti insieme fino alla laurea e, con alcuni, anche per molto tempo dopo. Le scomparse erano spesso legate a motivi economici. Bastava un 15 per perdere il presalario e, se la media scendeva sotto il 24 o si era in ritardo con gli esami, l’esenzione parziale dalle tasse, e con la media sotto il 27 e con due esami con meno di 24 si perdeva l’esenzione. Forse per gli studenti attuali è difficile rendersi conto di questi vincoli ma alla media del 24 arrivava solo il 15-20% degli studenti, per quella del 27 si scendeva all’1-2%. Uno dei docenti da cui ho imparato di più, poi, soleva dire: “Quando uno studente si siede davanti a me, ha diritto al voto; meno di 15 no perché è diseducativo, ma il 15 è assicurato.” Può sembrare una battuta neanche tanto felice ma era gente che sapeva le conseguenze di quello che faceva e se ne assumeva la responsabilità. Per quel che ho conosciuto dei docenti delle generazioni successive, questo principio è scomparso. Si può pensare perché sono più “umani” e comprensivi. Credo invece che sia la fuga dall'assumersi la responsabilità di fare selezione, sopportando i costi che ricadono sulla persona che promuove o boccia, e questo ha danneggiato di molto il processo formativo degli studenti, che, a quel che mi dicono, “tentano l’esame” anche quando un sommario esame di coscienza suggerirebbe loro di astenersi. I voti universitari hanno perso ogni valore di segnalazione della qualità dello studente. E la scomparsa dei processi di selezione, pur con i loro limiti e le loro ingiustizie, ha danneggiato moltissimo la società in tutti i campi.
Per inciso, si insegnava molto meno. Un corso prevedeva 45, raramente 50 lezioni di ¾ d’ora, solitamente ridotte a 40 o anche 30 minuti. In pochissimi si svolgeva tutto il programma da portare per l’esame (i preappelli erano molto popolari perché c’era uno sconto sulla materia da portare). C’erano esercitazioni solo nelle materie strettamente tecniche. La gran parte dei docenti erano bravissimi didatticamente ma rinunciare ad argomenti difficili per “farsi capire”, per non perdere studenti, era l’ultima delle loro preoccupazioni mentre cercavano invece di dare il meglio di quello che sapevano ed era lo studente che doveva preoccuparsi di prendere dalle lezioni il più che poteva. E quest’ultimo doveva completare la preparazione da solo o con i propri compagni: anche per questo il ruolo dei “pari” era fondamentale. Era la maniera in cui però si costringeva e si imparava ad auto-organizzarsi, a prendersi iniziative, ad essere via via meno dipendenti dai professori.
Non so se ho studiato molto, non mi sembra perché in quel periodo ho anche letto moltissimo, in maniera assolutamente disordinata, cose che non c’entravano nulla con la scuola, sono andato al cinema, ho giocato a ping pong e a carte. Ho imparato a giocare agli scacchi. Ma le cose che dovevo studiare mi piacevano e dedicavo loro, soprattutto a riscrivere gli appunti che prendevo a lezione, molto tempo. Riscrivere gli appunti era il momento che mi serviva per stabilire collegamenti con cose magari non trattate nel corso ma che avevo visto e che mi sembravano legate ad esse, pormi problemi, trovare curiosità, domande cui non sapevo rispondere. C’ero in parte costretto dal fatto che, per ragioni economiche, molti dei libri di testo sono riuscito ad averli quando ormai avevo superato l’esame. Questo mi aveva ad esempio costretto ad utilizzare un libro di matematica applicata per studiare anche la disciplina che mi interessava di più. Nel riscrivere gli appunti, vedere come si poteva usare il formalismo per riscrivere quello che ci era insegnato in maniera informale era una cosa che mi riempiva di assoluta goduria. Con questa tecnica, arrivavo alla fine del corso ben preparato. Nei primi esami sono stato molto fortunato e ho avuto una serie di voti molto alti nelle materie che erano ritenute più difficili e mi sono fatto subito la fama di uno bravo. Volevo sembrare intelligente, volevo che i miei compagni avessero una qualche ragione per stimarmi, per volermi con loro.
Non mi sono mai innamorato di nessuno di essi, che mi ricordi, neppure mi sembravano particolarmente belli. Il mio problema in quegli anni era la masturbazione. Mi vergognavo profondamente. Non so se ci credessi veramente o solo volessi crederlo, ma ritenevo che nessuno di loro lo facesse e il fatto che, nonostante i miei propositi, io ci ricascassi e spesso mi faceva sentire sporco.
Essere bravo a scuola era la maniera con cui cercavo di rendermi accettabile, di compensare le mie mancanze, ma non compensavo mai abbastanza.
Da quel che ho detto, è ovvio che, a parte le solite battute, la confidenza reciproca in materia di sesso fosse assai scarsa. Con molti di loro ci siamo frequentati per anni e alcuni sono ancora tra le persone che mi sono più vicine, ma non ho mai trovato il coraggio non dico di dire, ma neppure di accennare alla mia omosessualità. Credo però che allora non ne fossi convinto del tutto neppure io, anche se lo sospettavo. Non volevo ammetterlo e rimuovevo il problema con tutte le mie forze. L’importante mi sembrava fosse tenersi aperte più vie possibile, di studio, di carriera, non fare scelte che implicassero la rinuncia a qualunque possibilità, rimandarle a quando e a se fossero diventate inevitabili.
Che il problema esistesse però può essere indicato dal fatto che, anche e forse soprattutto nello studio, mi interessavano molto di più le eccezioni che non le regole, le condizioni e i limiti di validità di una teoria che le risposte che essa forniva. La mia tentazione era di cercare di riuscire a sovvertire il senso comune, dimostrare quanto fosse infondato, ingiustificato. È stata un’arma a due tagli. Mi ha reso molto, negli esami, sorprendendo il professore con risposte che non si aspettava. Mi ha anche spinto verso i temi meno frequentati, a stare dalla parte della minoranza, ad allontanarmi dalla teoria che allora sembrava dominante e di maggior successo, cosa che era rischiosa ma mi attirava. Il costo, emerso gradualmente e forse troppo tardi, era che neppure io potevo essere sicuro di nulla.
Non so se sia legato a questo fatto, ma in quel periodo mi sono anche reso conto di pregare in maniera sbagliata, per abitudine e forse un po’ per superstizione, per chiedere, per avere qualche cosa, un aiuto in cose basse ed irrilevanti come l’andare bene in un esame, più che per fede. Ho smesso la preghiera ma ho anche sostanzialmente abbandonato la Chiesa. Non che ne abbia mai fatto veramente parte: non sono mai riuscito ad inserirmi (o forse non mi hanno mai voluto) in un gruppo organizzato. Tutto andava bene fin quando il tutto era informale e un po’ casuale, senza regole, senza obblighi, più in là non riuscivo ad andare. Forse già alle superiori mi ero imbattuto in Renan e mi aveva fatto una grande impressione. Ho continuato ad andare a messa, a confessarmi e a fare la comunione, ma sempre più come gesti abitudinari cui, nel mio ambiente, nella mia famiglia in particolare, si era tenuti ma senza vera adesione. Del resto, avevo smesso di andare all’oratorio dai tredici o quattordici anni e credo che i preti della mia parrocchia non sapessero neppure della mia esistenza. Rendermi invisibile è una tecnica che ho imparato molto presto. La mia religione era ferma all’immagine che me ne ero fatta da bambino, oleografica, senza un vero significato, anche se oggi rivaluterei quel modo di vedere che era bastato ai miei nonni. Cristo e il cristianesimo restavano per me cose astratte, anche un po’ sospette, che avevano poco a che fare con la mia vita, i miei problemi. Quello che forse mi ha spinto maggiormente a sterilizzare e rendere puramente formale la mia partecipazione alla Chiesa era il fatto di non riuscire a rispettare i dettami di comportamento che predicava. Partecipare effettivamente alla sua vita, prendervi parte attiva, mi sembrava ipocrita pensando allo scarto tra l’immagine che avrei dovuto sostenere pubblicamente e come vivevo e cosa pensavo realmente. Anche qui, la scelta migliore mi sembrava quella di conformarmi nell’indispensabile ma restare in disparte.
Nel mio gruppetto di amici all’università ce n’erano alcuni molto religiosi. Mi invitarono anche ad un campo estivo. C’erano due preti e uno di essi faceva lezioni sul passo di san Paolo in cui parla del superamento della legge. Certo per le ragioni sbagliate, è stato quello che mi ha affascinato di più. Dormivo in tenda con un’altra decina di ragazzi. Una notte feci un sogno molto osé ed ebbi la netta sensazione di essermi anche sfregato contro uno dei paletti che reggeva la tenda. Il mattino, ero veramente imbarazzato nel trovarmi bagnato.
Oltretutto, so che mi capita di parlare nel sonno. Furono molto discreti. Nessuno disse niente, continuammo a vederci ma non fui più invitato ai loro incontri.
Io non sono mai riuscito a sentire e vivere la religione come loro. Tranne che per le correnti un po’ eterodosse, la predicazione mi sembrava trita. Era il tempo della Pacem in terris e della Populorum progressio. Mi sembravano cose piene di buone intenzioni ma senza alcun effetto ed alcuna rilevanza pratica. Dal punto di vista della teoria che usavano, mi sembravano arretrate, non tener conto dei progressi e problemi, più logici che altro, recenti. Ero già affascinato dalla filosofia anglosassone e la metafisica, per quel poco che ne conoscevo, mi sembrava parlare di cose morte e molto pressappoco. Provai anche a leggere gli olandesi ma senza capire gran che e cose come l’Isolotto di Firenze mi sembravano sospette, sono sempre stato un bieco conservatore, rimpiango il latino e il canto gregoriano. Delle virtù, mi interessano prudenza, fortezza e temperanza; quanto alla giustizia, uno deve cercare di essere giusto nel proprio modo di agire ma quando viene presa come sinonimo di giustizia sociale ho dei problemi. Nessun dubbio sulla sua importanza ma qualche volta chi vi insiste troppo lo fa per trasferire ad altri le proprie responsabilità personali e chi sa cosa bisogna fare per risolvere il problema dovrebbe tener conto che, da fonte autorevole, sappiamo che la giustizia non è di questo mondo. Mi interessava molto di più Marcuse o l’esistenzialismo francese, soprattutto Camus, molto meno Sartre, per quel che ne capivo.
Era anche il periodo del ’68, le occupazioni delle università, la contestazione. Anche qui mi trovai abbastanza isolato. Credevo che ci fosse bisogno di riforme ma non nella direzione di una minor selettività. Credevo che i ragazzi che venivano da ambienti svantaggiati dovessero in qualche modo essere compensati, direi essere aiutati e assistiti se le parole non suonassero così male, ma senza sconti. I provvedimenti che furono presi mi sembravano andare nella direzione opposta. Ci fu la liberalizzazione degli accessi, una misura eccessiva.
Peggio ancora, ci fu la liberalizzazione del piano di studi col risultato che gente che si è iscritta alla mia facoltà due o tre anni dopo di me ha potuto saltare esami che prima erano considerati fondamentali e in genere insegnati da docenti che io trovavo eccezionali. In compenso sono esplose le materie opzionali e si è persa la gerarchia tra materie veramente importanti e quelle riempitive, con la relativa graduazione dell’impegno richiesto agli studenti e dello status del docente.
Poi venne la stabilizzazione e persone che servivano solo per fare esami ed esercitazioni divennero professori, più tardi divennero persino ordinari.
Molte delle mie scelte di studio erano disapprovate in famiglia. Non sembravano le più adatte a prepararsi ad un lavoro che pagasse bene. Sembravano anche azzardate e i miei trascorsi non erano così brillanti da giustificare ottimismo.
Forse molte cose le ho fatte per puro spirito di contraddizione nei loro confronti. A casa ho sempre detto poco, non se sostenevo esami e che voti prendevo. Non volevo creare attese che magari avrei deluso, e forse non per tutti con dispiacere.
Finii l’università piuttosto bene. Dissi a mia madre che mi laureavo due o tre giorni prima. Venne alla discussione. È stata forse una delle poche soddisfazioni che le ho dato e anche questa, non nella maniera migliore. Avrei probabilmente potuto evitare di fare il servizio militare ma non ci provai nemmeno. Volevo fare quello che tutti gli altri facevano, dimostrare che anch’io ero in grado di fare tutto quello che un ragazzo normale era tenuto a fare. Pensavo anche che mi servisse una pausa. L’ultimo esame, ed era uno di quelli cui tenevo di più, l’avevo tirato con i denti e avevo fatto una figura barbina (me ne vergogno ancora), per fortuna senza conseguenze, ma solo per la generosità del docente.
Ero incerto sul contenuto della mia tesi. Sapevo che il mio relatore non era in grado di seguire la parte analitica ed io ero molto incerto su alcune varianti che avevo introdotto. Soprattutto, ero incerto sul suo senso, che rispondesse a quel che io nell’introduzione dicevo di cercare. Or ora mi sembrava che tutto fosse logicamente coerente, or ora mi sembrava affetto da contraddittorietà radicali. È un dubbio che mi è rimasto.
Il servizio militare non mi è servito a gran che. Come quasi tutti i laureati, feci il corso ufficiali. Con i miei soldati le cose andavano abbastanza bene. Credo che tutto sommato mi stimassero ma avevo paura a fraternizzare troppo con loro. Non ricordo di aver provato tentazioni ma non mi andava di essere falso. Per questo motivo, su molte cose, stavo molto sulle mie. Mi ricordo di averne sentito uno dire ad un altro che cercare di parlare con me era come gettare una palla contro un muro di gomma. Per la parte tecnica, credo di essere stato abbastanza bravo; un po’ meno, ma per trascuratezza e non per spirito di ribellione, dal punto di vista della forma. Era un periodo un po’ strano.
Potevo tenere in caserma il Capitale, la Monthly Review ma leggere il Giorno di quei tempi era visto come sovversivo. Devo ammettere che le note finali che ho letto sul foglio di congedo erano veritiere: “Manca di attitudine al comando”. Anche l’esperienza successiva le ha confermate.
Al ritorno, avevo due possibilità: continuare a fare ricerca procurandomi una borsa di studio o trovare subito un lavoro. Da quest’ultimo punto di vista, quello era un periodo d’oro: non c’erano problemi, in pratica non c’erano tempi di attesa. Anche qui, ci sono cose incomprensibili. Ai miei tempi le lezioni erano soprattutto teoriche. Il docente di cui ho parlato, nella prima lezione avvertiva che se uno si aspettava cose pratiche e di pronta applicazione aveva sbagliato corso. Oggi, da quel che si legge sui giornali, si vogliono corsi professionalizzanti. Quando eravamo poveri, potevamo permetterci di perdere tempo con la teoria e con la formazione a largo raggio; oggi che siamo, almeno lo siamo stati fino a poco tempo fa, ricchi vogliamo trasformare l’università in avviamento al lavoro specializzato, quando va bene. E dal risultato direi che facciamo fallimento su tutta la linea. D’altra parte è vero che, anche nel campo in cui lavoro, l’alta teoria è stata largamente abbandonata quasi dappertutto e soprattutto in molte delle università straniere che prendiamo ad esempio. Si fa molto, secondo me troppo, lavoro applicato. E questo si riflette nella rozzezza di molti dei libri che si fanno studiare oggi (ma è probabile che gli studenti di oggi abbiano capacità, sensibilità ed interessi diversi da quelli di una volta). Si vogliono le ricette su cosa fare, si vuole la verifica empirica quando i dati su cui ci si basa (per non parlare delle teorie che si usano) sono dubbi (se si vuol essere caritatevoli). E si danno suggerimenti che, proprio perché ignorano gran parte dei problemi teorici irrisolti che però avvertono della scarsa prevedibilità degli effetti delle strategie d’intervento adottate, sono pericolosissimi e, a mio parere, si sono anche dimostrati molto dannosi.
Avevo ricevuto un po’ di offerte interessanti ma feci un solo colloquio. Andò piuttosto bene e mi offrirono uno stipendio iniziale che era un 25 o 30% più alto di quello che guadagnava un mio compagno che lavorava lì da quasi due anni. Ma l’idea di poter continuare a studiare mi attirava troppo, era troppo disapprovata a casa e accettai la borsa di studio, un terzo di quel che avrei guadagnato lavorando e molto meno persino di quel che prendevo a militare.
Passai un anno in Italia e poi andai in Inghilterra per il dottorato. Già verso la fine dell’università ero un po’ cambiato, anche se non me ne rendevo bene conto. Mi ero accorto che abbandonavo argomenti che pure avevo studiato con passione una volta padroneggiata la struttura analitica. Non sopportavo più l’idea di subire esami, di seguire moduli prestabiliti, magari sovvertendoli un po’, ma proprio poco poco. Continuavo a voler distruggere la fiducia nel sensocomune, dimostrare che quello che tutti credevano e sostenevano era limitato, parziale se non del tutto sbagliato. Volevo sbriciolare la corazza degli altri, farli sentire nudi ed inermi, che anche loro avessero almeno lo stesso senso di insicurezza che avevo io, che anche loro si ponessero domande di senso cui sapevano di non saper rispondere, volevo addirittura costringerli ad abbandonare le loro idee su ciò che è naturale e ciò che non lo è e a giustificare il mio modo di essere. Tenevo, però tutto nel massimo segreto e il segreto mi pesava, e non volevo per niente che trapelassero i miei obiettivi e le mie motivazioni. Sicuramente era codardia della peggior specie, una caratteristica che purtroppo ho conservato.
Se non riuscivo ad avere idee nuove, le cose che sapevo mi sembravano senza interesse e passavo da un argomento all’altro. È stato un po’ defatigante e allora pensavo anche stupido e improduttivo. Paradossalmente, però, mi sembra che mi siano servite molto di più le cose “inutili” che ho letto e studiato senza uno scopo o una ragione che non quelle apparentemente più funzionali e motivate. Sull’argomento della tesi di laurea che avevo scelto, esisteva pochissima letteratura, in Italia in pratica era sconosciuto. Solo più tardi ho scoperto che proprio in quegli anni stava diventando uno dei più discussi in America, ma quei lavori sono arrivati in Italia quando io avevo già deciso di abbandonare quel campo. Sono stato comunque fortunato perché quella scelta ha attirato l’attenzione di uno dei professori più importanti dell’università inglese in cui sono finito tre anni dopo che proprio in quel campo aveva lavorato e che mi ha preso tra quelli cui faceva da supervisore.
I primi sei mesi sono stati durissimi, mi auguravo una polmonite per avere una scusa per rientrare e abbandonare tutto, ma poi, a poco a poco le cose si aggiustarono. Nel complesso, i miei docenti e i miei supervisori avevano una buona opinione di me, al punto da piegare anche qualche regola per farmi passare al dottorato vero e proprio: ero dovuto rientrare in Italia alla fine del secondo anno, prima di completare gli esami, e mi hanno consentito di completare la tesi e il periodo di residenza richiesto durante le estati successive.
Avevo inoltre dei compagni di corso e di college fantastici.
I miei obiettivi inconfessabili sono stati però anche una delle ragioni per cui ho sempre cercato di lavorare da solo. Questo ha complicato molto i rapporti con i miei docenti. Volevo essere libero di decidere per conto mio cosa studiare, su cosa impegnarmi. Forse era solo paura, e forse giustificata, di non riuscire a raggiungere gli standard che loro fissavano. Sia in Italia, sia in Inghilterra ho scelto argomenti di tesi che erano lontanissimi dagli interessi che i miei supervisori avevano, dai campi su cui loro stavano lavorando. Fortunatamente avevo imbroccato idee che incuriosivano anche loro e pensavano meritevoli di essere approfondite. Tutto sommato, non mi pento di quel che ho fatto, anche se questo atteggiamento mi ha spinto ancor più a cercare l’isolamento, ad evitare di mettere in evidenza i risultati che ottenevo. Riemergevano sempre l’insicurezza e il mio senso di incapacità ad affrontare l’incombente dimostrazione che avevo sbagliato tutto, che non avevo capito niente.
È stato in quel periodo, però, che non potei più nascondermi il fatto di essere gay. Non che facessi esperienze in questo campo. L’ambiente inglese era molto più aperto a queste possibilità, anche se non ho mai conosciuto qualcuno che si dichiarasse apertamente gay. Comunque le letture che circolavano, i libri che a poco a poco scoprivo mi confermavano sempre di più sulle mie inclinazioni. Sapevo però che si trattava di una scelta che mi avrebbe chiuso molte strade, molte possibilità, soprattutto in Italia ed io volevo ritornare.
È stato anche il periodo in cui ho fatto alcuni degli errori di cui mi sono pentito di più. È stato quello in cui mi sono rivelato improvvidamente e brutalmente al mio compagno all’istituto tecnico che avevo frequentato. Volevo che lui sapesse di me e che mi dicesse che andava bene. Lo feci però nella maniera più assurda e stupida. Gli dissi addirittura che poteva essere che la mia amicizia per lui fosse in realtà innamoramento, cosa certamente falsa. Non so se l’ho più deluso o spaventato e imbarazzato. Non mi scrisse più e neppure io lo feci. Un paio d’anni dopo mi mandò un cartoncino con l’annuncio di nozze. Lo presi come l’equivalente di un pugno sul naso.
Durante il periodo inglese conobbi anche un compagno iraniano. Mi piaceva moltissimo, come persona ma, ed era una cosa per molti versi nuova per me, anche fisicamente. Aveva degli occhi vivissimi e fantastici. C’è stata almeno un’occasione in cui avrei potuto sperimentare concretamente. Un pomeriggio andammo a nuotare e la sera mangiammo da me. La cosa imbarazzante è che avevo solo uova, piselli in scatola e carne di maiale. Mi disse che per lui, anche se era musulmano, non c’erano problemi. Contro i precetti della sua religione, bevemmo parecchio whisky. Mi propose di restare a dormire con me. Purtroppo sapevo che avevamo bevuto un po’ troppo o forse avevo solo paura di cosa avrebbe pensato il mattino dopo e gli dissi di no. Non avevo ancora capito la saggezza del detto che vuole che sia meglio un rimorso piuttosto che un rimpianto. Mi chiedo cosa diavolo avremmo fatto. Le mie idee sul sesso gay erano ancora piuttosto vaghe ed incomplete. La pornografia l’ho scoperta solo qualche anno dopo.
Al ritorno in Italia ho avuto la possibilità di continuare a fare ricerca. Mi ero fatto la fama di quello che vive nella sua torre d’avorio e, di fatto, studiavo cose molto astratte e del tutto incompatibili con la corrente allora dominante nel mio campo in Italia. Forse un po’ incoscientemente la cosa non mi infastidiva o preoccupava per nulla. Ero abituato a lavorare da solo, forse era quello che desideravo maggiormente e avevo la convinzione che l’indirizzo che seguivo fosse quello giusto, che gli altri non lo seguissero solo perché era difficile e pieno di domande su cui non si sapeva cosa rispondere: dava largo spazio ai teoremi di impossibilità, a dimostrazioni di inesistenza di soluzioni con proprietà minime di accettabilità a problemi che tutti prima ritenevano ovviamente risolvibili se non già risolti.
È stato allora che ho rincontrato la ragazza che anni prima mi aveva regalato una scatola di fiammiferi controvento. Era una persona sorprendentemente libera, con cui potevo parlare di tutto, sesso compreso, dei miei dubbi. Passavo interi pomeriggi a parlare con lei. Le interessava Marcuse, soprattutto quello di Eros e civiltà, la psicologia, compreso Reich. Non credo che fossimo innamorati, anche se, per me, è stata la cosa più vicina ad esserlo; non per lei però. È stato con lei che sono andato il più vicino ad avere un rapporto completo. Nonostante lei fosse piuttosto libera in materia di sesso, o almeno dicesse di esserlo, con me c’era sempre qualcosa che impediva che si andasse oltre un certo stadio.
Gradualmente ho scoperto che anche lei stava chiedendosi se non fosse lesbica e cominciava a sperimentare in quella direzione. Purtroppo, durante una sua vacanza in Grecia mi mandò una cartolina da Mykonos nel posto in cui lavoravo che a me sembrava troppo esplicita su di me. Il fatto che fosse troppo facilmente leggibile mi spaventò. La interpretai come un gesto ispirato da invidia per le strade che sembravano aprirsi per me e interruppi praticamente ogni rapporto con lei. Soprattutto per colpa mia, non siamo mai riusciti a rappacificarci.
___________________
Non ho avuto problemi né nella scelta dell’università né in quella della facoltà perché le alternative erano poche. Nella mia regione allora c’erano quattro università e da questo punto di vista era molto ricca: ce n’erano molte che non ne avevano neanche una. Adesso, qui, credo che siano una decina e il numero di facoltà e corsi di laurea è esploso.
Certamente mi lascio prendere dalla nostalgia ma credo che il vecchio assetto avesse dei vantaggi, molto costosi, che sono andati irrimediabilmente, ma per altri versi fortunatamente, persi. Tranne che per i pochi che venivano da famiglie in cui i genitori erano professionisti, iscriversi all’università voleva dire staccarsi dalla famiglia, talvolta anche materialmente, ma soprattutto psicologicamente. In un paese di sette o ottomila abitanti, nel mio anno credo che lo facessimo in due o tre, in tutto, gli universitari saranno stati una decina: iscriversi era entrare in un’élite molto limitata e staccata dalla vita del resto della comunità.
Andare all’università costava, in tasse, libri e trasporti, quando si poteva fare il pendolare, o affitto di stanze altrimenti, ma soprattutto in mancati redditi (un ragioniere, un perito o un geometra non avevano problemi a trovare un lavoro ed uno stipendio adeguato). Era una scelta che si sapeva rischiosa e che avrebbe eventualmente dato frutti solo dopo quattro, di solito cinque o sei anni. Questo incideva sull’ottica che gli studenti avevano: lo studio era visto come un privilegio e diventava il più importante impegno, qualcosa che assorbiva a tempo pieno, che non poteva essere sacrificato ad altro. Si garantiva agli studenti autonomia ma anche responsabilità. Laurearsi possibilmente bene e presto era l’obiettivo di tutta la famiglia che faceva il possibile per mettere nelle condizioni di raggiungere l’obiettivo ma questo decideva anche quale fosse il dovere dello studente e il comportamento da tenere: lamentarsi della sfortuna o del professore carogna non era accettato facilmente da gente che lavorava in fabbrica, e nelle fabbriche di allora con sindacati molto più deboli, o nei campi.
Inoltre, l’aumento di coloro che si iscrivono all’università è certamente un segno positivo ma indica anche il fatto che diventa una scelta molto meno libera e impegnativa di un tempo. Oggi si è in pratica obbligati a diplomarsi e la pressione della famiglia e dei pari per iscriversi all’università è molto forte, soprattutto se non si trova subito un lavoro.
L’uso che si faceva del tempo era interamente responsabilità propria ed era sentita come tale. E anche il tempo era diverso: gli usi che se ne potevano fare erano molto più limitati. Non c’erano telefonini e anche le case con telefono erano poche. Relativamente pochi avevano un’auto in famiglia e la patente. La televisione si è diffusa soprattutto negli anni ’60 e offriva spazi limitati: c’erano solo due canali e solo in alcune regioni si poteva vedere la Svizzera, non c’erano trasmissioni il mattino e la sera per le undici era finito tutto. Non c’erano l’happy hour e i pub, neppure Burghy e sushi bar, al massimo osterie.
Durante la settimana non c’erano discoteche e anche il sabato e la domenica, c’erano le balere senza disk jockey. Non c’erano cd, mp3 e altre diavolerie. C’era molto più tempo per leggere e pensare in solitudine senza dover rinunciare ad altro.
Nella mia università, almeno un 30% degli iscritti veniva da altre regioni e finiva per viverci tutto il giorno. Averla sotto casa ha abbattuto i costi che si devono sostenere, ha permesso a molti che altrimenti sarebbero stati esclusi per motivi economici di frequentarla. Ma ha avuto anche aspetti negativi. Molte delle nuove università sono partite senza strutture materiali (edifici, biblioteche, mense, ecc.) adeguate e senza una tradizione alle spalle. Il corpo docente era spesso pendolare e quindi non sempre presente e sempre di corsa, non sempre era scelto in maniera accurata, solitamente non vedeva la sede in cui insegnava come la propria meta finale ma più un ripiego in attesa di raggiungere sedi più prestigiose.
Col tempo alcuni di questi difetti sono stati almeno in parte corretti ma molto era ormai perso per sempre. L’università di allora era aperta e gli studenti ci restavano fino a tardi la sera. Accanto ai corsi, c’erano cicli di film, qualche concerto, cori, ecc., che credo siano scomparsi. Averla vicino a casa ha finito per rendere la casa più attraente dell’università e lo studio solo uno tra i molti impegni. Paradossalmente, molto più oggi di allora, si sente dire di conti su quante ore di lezione giustifichino l’andarci, che è la morte dell’esperienza universitaria e così finiamo per esaltare l’Erasmus.
Anche per quanto riguarda la scelta della facoltà, per chi veniva dagli istituti tecnici, c’erano, credo abbastanza giustamente, anche se forse esagerando, poche alternative, per chi veniva dalle magistrali c’era solo Magistero. Nel mio caso, poi, la decisione è stata largamente determinata da banali problemi logistici. Le mie preferenze andavano ad un’altra università, dove c’era un professore molto noto e che scriveva di cose un po’ astruse ma che mi sembravano interessanti. Venendo da un istituto tecnico, ho sempre aspirato alla “alta cultura”, a quella raffinata ed eterea che a me era mancata e manca.
Di quella in cui ho finito per iscrivermi, nessuno dei docenti era particolarmente noto. Credo che, seguendo le mie preferenze, avrei fatto una scelta sbagliata. Il professore che mi interessava era alla fine della sua carriera e credo avesse già dato tutto quello che aveva da dare. Ho anche provato a leggere alcuni dei suoi libri e li ho trovati certamente bizzarri ma assolutamente incomprensibili ed indigeribili. In quella in cui sono andato, nelle discipline che mi interessavano di più, insegnavano docenti giovani, all’inizio della loro carriera, appena ritornati da studi all’estero, chi in Inghilterra, chi in Francia, chi negli Stati Uniti, e pieni di entusiasmo. Credo di essere stato fortunato nel poter evitare le lezioni del “grande vecchio” locale.
Si parla molto di internazionalizzazione, di imitare le università straniere nell’organizzazione dei corsi, nei programmi, nell’insegnamento in inglese (ignorando il deprecabile livello di conoscenza linguistica di gran parte di chi dovrebbe farlo). Quando la nostra università era “chiusa”, almeno per quel che riguarda la mia esperienza, era molto più aperta al clima internazionale di oggi: quando ho poi seguito corsi di specializzazione all’estero, mi sono reso conto che molti dei libri in uso per i master fuori io li conoscevo già, e molti dei nostri testi erano assolutamente dello stesso livello. Non ho visto un mondo nuovo come è capitato a generazioni anche di poco successive. Io ho frequentato l’università da pendolare, continuando ad abitare a casa e facendomi due ore, quando andava bene, di treno il giorno, per altro molto produttive. Allora riuscivo ad isolarmi e studiare anche in vetture molto affollate e gelide o infuocate e ho letto e imparato moltissimo in quelle ore.
Formalmente, la frequenza era obbligatoria ma non c’erano veri controlli. Io però, fin dall’inizio, ho sempre frequentato. In pratica andavo in università dal lunedì al sabato, perché allora si facevano lezioni anche il sabato, dalle 8,30 del mattino alle 18,30 della sera, il sabato solo fino alle 13,30.
Quasi da subito, si è formato un gruppetto. Abbiamo presto fraternizzato e, con qualche scomparsa negli anni, siamo rimasti insieme fino alla laurea e, con alcuni, anche per molto tempo dopo. Le scomparse erano spesso legate a motivi economici. Bastava un 15 per perdere il presalario e, se la media scendeva sotto il 24 o si era in ritardo con gli esami, l’esenzione parziale dalle tasse, e con la media sotto il 27 e con due esami con meno di 24 si perdeva l’esenzione. Forse per gli studenti attuali è difficile rendersi conto di questi vincoli ma alla media del 24 arrivava solo il 15-20% degli studenti, per quella del 27 si scendeva all’1-2%. Uno dei docenti da cui ho imparato di più, poi, soleva dire: “Quando uno studente si siede davanti a me, ha diritto al voto; meno di 15 no perché è diseducativo, ma il 15 è assicurato.” Può sembrare una battuta neanche tanto felice ma era gente che sapeva le conseguenze di quello che faceva e se ne assumeva la responsabilità. Per quel che ho conosciuto dei docenti delle generazioni successive, questo principio è scomparso. Si può pensare perché sono più “umani” e comprensivi. Credo invece che sia la fuga dall'assumersi la responsabilità di fare selezione, sopportando i costi che ricadono sulla persona che promuove o boccia, e questo ha danneggiato di molto il processo formativo degli studenti, che, a quel che mi dicono, “tentano l’esame” anche quando un sommario esame di coscienza suggerirebbe loro di astenersi. I voti universitari hanno perso ogni valore di segnalazione della qualità dello studente. E la scomparsa dei processi di selezione, pur con i loro limiti e le loro ingiustizie, ha danneggiato moltissimo la società in tutti i campi.
Per inciso, si insegnava molto meno. Un corso prevedeva 45, raramente 50 lezioni di ¾ d’ora, solitamente ridotte a 40 o anche 30 minuti. In pochissimi si svolgeva tutto il programma da portare per l’esame (i preappelli erano molto popolari perché c’era uno sconto sulla materia da portare). C’erano esercitazioni solo nelle materie strettamente tecniche. La gran parte dei docenti erano bravissimi didatticamente ma rinunciare ad argomenti difficili per “farsi capire”, per non perdere studenti, era l’ultima delle loro preoccupazioni mentre cercavano invece di dare il meglio di quello che sapevano ed era lo studente che doveva preoccuparsi di prendere dalle lezioni il più che poteva. E quest’ultimo doveva completare la preparazione da solo o con i propri compagni: anche per questo il ruolo dei “pari” era fondamentale. Era la maniera in cui però si costringeva e si imparava ad auto-organizzarsi, a prendersi iniziative, ad essere via via meno dipendenti dai professori.
Non so se ho studiato molto, non mi sembra perché in quel periodo ho anche letto moltissimo, in maniera assolutamente disordinata, cose che non c’entravano nulla con la scuola, sono andato al cinema, ho giocato a ping pong e a carte. Ho imparato a giocare agli scacchi. Ma le cose che dovevo studiare mi piacevano e dedicavo loro, soprattutto a riscrivere gli appunti che prendevo a lezione, molto tempo. Riscrivere gli appunti era il momento che mi serviva per stabilire collegamenti con cose magari non trattate nel corso ma che avevo visto e che mi sembravano legate ad esse, pormi problemi, trovare curiosità, domande cui non sapevo rispondere. C’ero in parte costretto dal fatto che, per ragioni economiche, molti dei libri di testo sono riuscito ad averli quando ormai avevo superato l’esame. Questo mi aveva ad esempio costretto ad utilizzare un libro di matematica applicata per studiare anche la disciplina che mi interessava di più. Nel riscrivere gli appunti, vedere come si poteva usare il formalismo per riscrivere quello che ci era insegnato in maniera informale era una cosa che mi riempiva di assoluta goduria. Con questa tecnica, arrivavo alla fine del corso ben preparato. Nei primi esami sono stato molto fortunato e ho avuto una serie di voti molto alti nelle materie che erano ritenute più difficili e mi sono fatto subito la fama di uno bravo. Volevo sembrare intelligente, volevo che i miei compagni avessero una qualche ragione per stimarmi, per volermi con loro.
Non mi sono mai innamorato di nessuno di essi, che mi ricordi, neppure mi sembravano particolarmente belli. Il mio problema in quegli anni era la masturbazione. Mi vergognavo profondamente. Non so se ci credessi veramente o solo volessi crederlo, ma ritenevo che nessuno di loro lo facesse e il fatto che, nonostante i miei propositi, io ci ricascassi e spesso mi faceva sentire sporco.
Essere bravo a scuola era la maniera con cui cercavo di rendermi accettabile, di compensare le mie mancanze, ma non compensavo mai abbastanza.
Da quel che ho detto, è ovvio che, a parte le solite battute, la confidenza reciproca in materia di sesso fosse assai scarsa. Con molti di loro ci siamo frequentati per anni e alcuni sono ancora tra le persone che mi sono più vicine, ma non ho mai trovato il coraggio non dico di dire, ma neppure di accennare alla mia omosessualità. Credo però che allora non ne fossi convinto del tutto neppure io, anche se lo sospettavo. Non volevo ammetterlo e rimuovevo il problema con tutte le mie forze. L’importante mi sembrava fosse tenersi aperte più vie possibile, di studio, di carriera, non fare scelte che implicassero la rinuncia a qualunque possibilità, rimandarle a quando e a se fossero diventate inevitabili.
Che il problema esistesse però può essere indicato dal fatto che, anche e forse soprattutto nello studio, mi interessavano molto di più le eccezioni che non le regole, le condizioni e i limiti di validità di una teoria che le risposte che essa forniva. La mia tentazione era di cercare di riuscire a sovvertire il senso comune, dimostrare quanto fosse infondato, ingiustificato. È stata un’arma a due tagli. Mi ha reso molto, negli esami, sorprendendo il professore con risposte che non si aspettava. Mi ha anche spinto verso i temi meno frequentati, a stare dalla parte della minoranza, ad allontanarmi dalla teoria che allora sembrava dominante e di maggior successo, cosa che era rischiosa ma mi attirava. Il costo, emerso gradualmente e forse troppo tardi, era che neppure io potevo essere sicuro di nulla.
Non so se sia legato a questo fatto, ma in quel periodo mi sono anche reso conto di pregare in maniera sbagliata, per abitudine e forse un po’ per superstizione, per chiedere, per avere qualche cosa, un aiuto in cose basse ed irrilevanti come l’andare bene in un esame, più che per fede. Ho smesso la preghiera ma ho anche sostanzialmente abbandonato la Chiesa. Non che ne abbia mai fatto veramente parte: non sono mai riuscito ad inserirmi (o forse non mi hanno mai voluto) in un gruppo organizzato. Tutto andava bene fin quando il tutto era informale e un po’ casuale, senza regole, senza obblighi, più in là non riuscivo ad andare. Forse già alle superiori mi ero imbattuto in Renan e mi aveva fatto una grande impressione. Ho continuato ad andare a messa, a confessarmi e a fare la comunione, ma sempre più come gesti abitudinari cui, nel mio ambiente, nella mia famiglia in particolare, si era tenuti ma senza vera adesione. Del resto, avevo smesso di andare all’oratorio dai tredici o quattordici anni e credo che i preti della mia parrocchia non sapessero neppure della mia esistenza. Rendermi invisibile è una tecnica che ho imparato molto presto. La mia religione era ferma all’immagine che me ne ero fatta da bambino, oleografica, senza un vero significato, anche se oggi rivaluterei quel modo di vedere che era bastato ai miei nonni. Cristo e il cristianesimo restavano per me cose astratte, anche un po’ sospette, che avevano poco a che fare con la mia vita, i miei problemi. Quello che forse mi ha spinto maggiormente a sterilizzare e rendere puramente formale la mia partecipazione alla Chiesa era il fatto di non riuscire a rispettare i dettami di comportamento che predicava. Partecipare effettivamente alla sua vita, prendervi parte attiva, mi sembrava ipocrita pensando allo scarto tra l’immagine che avrei dovuto sostenere pubblicamente e come vivevo e cosa pensavo realmente. Anche qui, la scelta migliore mi sembrava quella di conformarmi nell’indispensabile ma restare in disparte.
Nel mio gruppetto di amici all’università ce n’erano alcuni molto religiosi. Mi invitarono anche ad un campo estivo. C’erano due preti e uno di essi faceva lezioni sul passo di san Paolo in cui parla del superamento della legge. Certo per le ragioni sbagliate, è stato quello che mi ha affascinato di più. Dormivo in tenda con un’altra decina di ragazzi. Una notte feci un sogno molto osé ed ebbi la netta sensazione di essermi anche sfregato contro uno dei paletti che reggeva la tenda. Il mattino, ero veramente imbarazzato nel trovarmi bagnato.
Oltretutto, so che mi capita di parlare nel sonno. Furono molto discreti. Nessuno disse niente, continuammo a vederci ma non fui più invitato ai loro incontri.
Io non sono mai riuscito a sentire e vivere la religione come loro. Tranne che per le correnti un po’ eterodosse, la predicazione mi sembrava trita. Era il tempo della Pacem in terris e della Populorum progressio. Mi sembravano cose piene di buone intenzioni ma senza alcun effetto ed alcuna rilevanza pratica. Dal punto di vista della teoria che usavano, mi sembravano arretrate, non tener conto dei progressi e problemi, più logici che altro, recenti. Ero già affascinato dalla filosofia anglosassone e la metafisica, per quel poco che ne conoscevo, mi sembrava parlare di cose morte e molto pressappoco. Provai anche a leggere gli olandesi ma senza capire gran che e cose come l’Isolotto di Firenze mi sembravano sospette, sono sempre stato un bieco conservatore, rimpiango il latino e il canto gregoriano. Delle virtù, mi interessano prudenza, fortezza e temperanza; quanto alla giustizia, uno deve cercare di essere giusto nel proprio modo di agire ma quando viene presa come sinonimo di giustizia sociale ho dei problemi. Nessun dubbio sulla sua importanza ma qualche volta chi vi insiste troppo lo fa per trasferire ad altri le proprie responsabilità personali e chi sa cosa bisogna fare per risolvere il problema dovrebbe tener conto che, da fonte autorevole, sappiamo che la giustizia non è di questo mondo. Mi interessava molto di più Marcuse o l’esistenzialismo francese, soprattutto Camus, molto meno Sartre, per quel che ne capivo.
Era anche il periodo del ’68, le occupazioni delle università, la contestazione. Anche qui mi trovai abbastanza isolato. Credevo che ci fosse bisogno di riforme ma non nella direzione di una minor selettività. Credevo che i ragazzi che venivano da ambienti svantaggiati dovessero in qualche modo essere compensati, direi essere aiutati e assistiti se le parole non suonassero così male, ma senza sconti. I provvedimenti che furono presi mi sembravano andare nella direzione opposta. Ci fu la liberalizzazione degli accessi, una misura eccessiva.
Peggio ancora, ci fu la liberalizzazione del piano di studi col risultato che gente che si è iscritta alla mia facoltà due o tre anni dopo di me ha potuto saltare esami che prima erano considerati fondamentali e in genere insegnati da docenti che io trovavo eccezionali. In compenso sono esplose le materie opzionali e si è persa la gerarchia tra materie veramente importanti e quelle riempitive, con la relativa graduazione dell’impegno richiesto agli studenti e dello status del docente.
Poi venne la stabilizzazione e persone che servivano solo per fare esami ed esercitazioni divennero professori, più tardi divennero persino ordinari.
Molte delle mie scelte di studio erano disapprovate in famiglia. Non sembravano le più adatte a prepararsi ad un lavoro che pagasse bene. Sembravano anche azzardate e i miei trascorsi non erano così brillanti da giustificare ottimismo.
Forse molte cose le ho fatte per puro spirito di contraddizione nei loro confronti. A casa ho sempre detto poco, non se sostenevo esami e che voti prendevo. Non volevo creare attese che magari avrei deluso, e forse non per tutti con dispiacere.
Finii l’università piuttosto bene. Dissi a mia madre che mi laureavo due o tre giorni prima. Venne alla discussione. È stata forse una delle poche soddisfazioni che le ho dato e anche questa, non nella maniera migliore. Avrei probabilmente potuto evitare di fare il servizio militare ma non ci provai nemmeno. Volevo fare quello che tutti gli altri facevano, dimostrare che anch’io ero in grado di fare tutto quello che un ragazzo normale era tenuto a fare. Pensavo anche che mi servisse una pausa. L’ultimo esame, ed era uno di quelli cui tenevo di più, l’avevo tirato con i denti e avevo fatto una figura barbina (me ne vergogno ancora), per fortuna senza conseguenze, ma solo per la generosità del docente.
Ero incerto sul contenuto della mia tesi. Sapevo che il mio relatore non era in grado di seguire la parte analitica ed io ero molto incerto su alcune varianti che avevo introdotto. Soprattutto, ero incerto sul suo senso, che rispondesse a quel che io nell’introduzione dicevo di cercare. Or ora mi sembrava che tutto fosse logicamente coerente, or ora mi sembrava affetto da contraddittorietà radicali. È un dubbio che mi è rimasto.
Il servizio militare non mi è servito a gran che. Come quasi tutti i laureati, feci il corso ufficiali. Con i miei soldati le cose andavano abbastanza bene. Credo che tutto sommato mi stimassero ma avevo paura a fraternizzare troppo con loro. Non ricordo di aver provato tentazioni ma non mi andava di essere falso. Per questo motivo, su molte cose, stavo molto sulle mie. Mi ricordo di averne sentito uno dire ad un altro che cercare di parlare con me era come gettare una palla contro un muro di gomma. Per la parte tecnica, credo di essere stato abbastanza bravo; un po’ meno, ma per trascuratezza e non per spirito di ribellione, dal punto di vista della forma. Era un periodo un po’ strano.
Potevo tenere in caserma il Capitale, la Monthly Review ma leggere il Giorno di quei tempi era visto come sovversivo. Devo ammettere che le note finali che ho letto sul foglio di congedo erano veritiere: “Manca di attitudine al comando”. Anche l’esperienza successiva le ha confermate.
Al ritorno, avevo due possibilità: continuare a fare ricerca procurandomi una borsa di studio o trovare subito un lavoro. Da quest’ultimo punto di vista, quello era un periodo d’oro: non c’erano problemi, in pratica non c’erano tempi di attesa. Anche qui, ci sono cose incomprensibili. Ai miei tempi le lezioni erano soprattutto teoriche. Il docente di cui ho parlato, nella prima lezione avvertiva che se uno si aspettava cose pratiche e di pronta applicazione aveva sbagliato corso. Oggi, da quel che si legge sui giornali, si vogliono corsi professionalizzanti. Quando eravamo poveri, potevamo permetterci di perdere tempo con la teoria e con la formazione a largo raggio; oggi che siamo, almeno lo siamo stati fino a poco tempo fa, ricchi vogliamo trasformare l’università in avviamento al lavoro specializzato, quando va bene. E dal risultato direi che facciamo fallimento su tutta la linea. D’altra parte è vero che, anche nel campo in cui lavoro, l’alta teoria è stata largamente abbandonata quasi dappertutto e soprattutto in molte delle università straniere che prendiamo ad esempio. Si fa molto, secondo me troppo, lavoro applicato. E questo si riflette nella rozzezza di molti dei libri che si fanno studiare oggi (ma è probabile che gli studenti di oggi abbiano capacità, sensibilità ed interessi diversi da quelli di una volta). Si vogliono le ricette su cosa fare, si vuole la verifica empirica quando i dati su cui ci si basa (per non parlare delle teorie che si usano) sono dubbi (se si vuol essere caritatevoli). E si danno suggerimenti che, proprio perché ignorano gran parte dei problemi teorici irrisolti che però avvertono della scarsa prevedibilità degli effetti delle strategie d’intervento adottate, sono pericolosissimi e, a mio parere, si sono anche dimostrati molto dannosi.
Avevo ricevuto un po’ di offerte interessanti ma feci un solo colloquio. Andò piuttosto bene e mi offrirono uno stipendio iniziale che era un 25 o 30% più alto di quello che guadagnava un mio compagno che lavorava lì da quasi due anni. Ma l’idea di poter continuare a studiare mi attirava troppo, era troppo disapprovata a casa e accettai la borsa di studio, un terzo di quel che avrei guadagnato lavorando e molto meno persino di quel che prendevo a militare.
Passai un anno in Italia e poi andai in Inghilterra per il dottorato. Già verso la fine dell’università ero un po’ cambiato, anche se non me ne rendevo bene conto. Mi ero accorto che abbandonavo argomenti che pure avevo studiato con passione una volta padroneggiata la struttura analitica. Non sopportavo più l’idea di subire esami, di seguire moduli prestabiliti, magari sovvertendoli un po’, ma proprio poco poco. Continuavo a voler distruggere la fiducia nel sensocomune, dimostrare che quello che tutti credevano e sostenevano era limitato, parziale se non del tutto sbagliato. Volevo sbriciolare la corazza degli altri, farli sentire nudi ed inermi, che anche loro avessero almeno lo stesso senso di insicurezza che avevo io, che anche loro si ponessero domande di senso cui sapevano di non saper rispondere, volevo addirittura costringerli ad abbandonare le loro idee su ciò che è naturale e ciò che non lo è e a giustificare il mio modo di essere. Tenevo, però tutto nel massimo segreto e il segreto mi pesava, e non volevo per niente che trapelassero i miei obiettivi e le mie motivazioni. Sicuramente era codardia della peggior specie, una caratteristica che purtroppo ho conservato.
Se non riuscivo ad avere idee nuove, le cose che sapevo mi sembravano senza interesse e passavo da un argomento all’altro. È stato un po’ defatigante e allora pensavo anche stupido e improduttivo. Paradossalmente, però, mi sembra che mi siano servite molto di più le cose “inutili” che ho letto e studiato senza uno scopo o una ragione che non quelle apparentemente più funzionali e motivate. Sull’argomento della tesi di laurea che avevo scelto, esisteva pochissima letteratura, in Italia in pratica era sconosciuto. Solo più tardi ho scoperto che proprio in quegli anni stava diventando uno dei più discussi in America, ma quei lavori sono arrivati in Italia quando io avevo già deciso di abbandonare quel campo. Sono stato comunque fortunato perché quella scelta ha attirato l’attenzione di uno dei professori più importanti dell’università inglese in cui sono finito tre anni dopo che proprio in quel campo aveva lavorato e che mi ha preso tra quelli cui faceva da supervisore.
I primi sei mesi sono stati durissimi, mi auguravo una polmonite per avere una scusa per rientrare e abbandonare tutto, ma poi, a poco a poco le cose si aggiustarono. Nel complesso, i miei docenti e i miei supervisori avevano una buona opinione di me, al punto da piegare anche qualche regola per farmi passare al dottorato vero e proprio: ero dovuto rientrare in Italia alla fine del secondo anno, prima di completare gli esami, e mi hanno consentito di completare la tesi e il periodo di residenza richiesto durante le estati successive.
Avevo inoltre dei compagni di corso e di college fantastici.
I miei obiettivi inconfessabili sono stati però anche una delle ragioni per cui ho sempre cercato di lavorare da solo. Questo ha complicato molto i rapporti con i miei docenti. Volevo essere libero di decidere per conto mio cosa studiare, su cosa impegnarmi. Forse era solo paura, e forse giustificata, di non riuscire a raggiungere gli standard che loro fissavano. Sia in Italia, sia in Inghilterra ho scelto argomenti di tesi che erano lontanissimi dagli interessi che i miei supervisori avevano, dai campi su cui loro stavano lavorando. Fortunatamente avevo imbroccato idee che incuriosivano anche loro e pensavano meritevoli di essere approfondite. Tutto sommato, non mi pento di quel che ho fatto, anche se questo atteggiamento mi ha spinto ancor più a cercare l’isolamento, ad evitare di mettere in evidenza i risultati che ottenevo. Riemergevano sempre l’insicurezza e il mio senso di incapacità ad affrontare l’incombente dimostrazione che avevo sbagliato tutto, che non avevo capito niente.
È stato in quel periodo, però, che non potei più nascondermi il fatto di essere gay. Non che facessi esperienze in questo campo. L’ambiente inglese era molto più aperto a queste possibilità, anche se non ho mai conosciuto qualcuno che si dichiarasse apertamente gay. Comunque le letture che circolavano, i libri che a poco a poco scoprivo mi confermavano sempre di più sulle mie inclinazioni. Sapevo però che si trattava di una scelta che mi avrebbe chiuso molte strade, molte possibilità, soprattutto in Italia ed io volevo ritornare.
È stato anche il periodo in cui ho fatto alcuni degli errori di cui mi sono pentito di più. È stato quello in cui mi sono rivelato improvvidamente e brutalmente al mio compagno all’istituto tecnico che avevo frequentato. Volevo che lui sapesse di me e che mi dicesse che andava bene. Lo feci però nella maniera più assurda e stupida. Gli dissi addirittura che poteva essere che la mia amicizia per lui fosse in realtà innamoramento, cosa certamente falsa. Non so se l’ho più deluso o spaventato e imbarazzato. Non mi scrisse più e neppure io lo feci. Un paio d’anni dopo mi mandò un cartoncino con l’annuncio di nozze. Lo presi come l’equivalente di un pugno sul naso.
Durante il periodo inglese conobbi anche un compagno iraniano. Mi piaceva moltissimo, come persona ma, ed era una cosa per molti versi nuova per me, anche fisicamente. Aveva degli occhi vivissimi e fantastici. C’è stata almeno un’occasione in cui avrei potuto sperimentare concretamente. Un pomeriggio andammo a nuotare e la sera mangiammo da me. La cosa imbarazzante è che avevo solo uova, piselli in scatola e carne di maiale. Mi disse che per lui, anche se era musulmano, non c’erano problemi. Contro i precetti della sua religione, bevemmo parecchio whisky. Mi propose di restare a dormire con me. Purtroppo sapevo che avevamo bevuto un po’ troppo o forse avevo solo paura di cosa avrebbe pensato il mattino dopo e gli dissi di no. Non avevo ancora capito la saggezza del detto che vuole che sia meglio un rimorso piuttosto che un rimpianto. Mi chiedo cosa diavolo avremmo fatto. Le mie idee sul sesso gay erano ancora piuttosto vaghe ed incomplete. La pornografia l’ho scoperta solo qualche anno dopo.
Al ritorno in Italia ho avuto la possibilità di continuare a fare ricerca. Mi ero fatto la fama di quello che vive nella sua torre d’avorio e, di fatto, studiavo cose molto astratte e del tutto incompatibili con la corrente allora dominante nel mio campo in Italia. Forse un po’ incoscientemente la cosa non mi infastidiva o preoccupava per nulla. Ero abituato a lavorare da solo, forse era quello che desideravo maggiormente e avevo la convinzione che l’indirizzo che seguivo fosse quello giusto, che gli altri non lo seguissero solo perché era difficile e pieno di domande su cui non si sapeva cosa rispondere: dava largo spazio ai teoremi di impossibilità, a dimostrazioni di inesistenza di soluzioni con proprietà minime di accettabilità a problemi che tutti prima ritenevano ovviamente risolvibili se non già risolti.
È stato allora che ho rincontrato la ragazza che anni prima mi aveva regalato una scatola di fiammiferi controvento. Era una persona sorprendentemente libera, con cui potevo parlare di tutto, sesso compreso, dei miei dubbi. Passavo interi pomeriggi a parlare con lei. Le interessava Marcuse, soprattutto quello di Eros e civiltà, la psicologia, compreso Reich. Non credo che fossimo innamorati, anche se, per me, è stata la cosa più vicina ad esserlo; non per lei però. È stato con lei che sono andato il più vicino ad avere un rapporto completo. Nonostante lei fosse piuttosto libera in materia di sesso, o almeno dicesse di esserlo, con me c’era sempre qualcosa che impediva che si andasse oltre un certo stadio.
Gradualmente ho scoperto che anche lei stava chiedendosi se non fosse lesbica e cominciava a sperimentare in quella direzione. Purtroppo, durante una sua vacanza in Grecia mi mandò una cartolina da Mykonos nel posto in cui lavoravo che a me sembrava troppo esplicita su di me. Il fatto che fosse troppo facilmente leggibile mi spaventò. La interpretai come un gesto ispirato da invidia per le strade che sembravano aprirsi per me e interruppi praticamente ogni rapporto con lei. Soprattutto per colpa mia, non siamo mai riusciti a rappacificarci.
BLOG PROGETTO GAY http://progettogay.myblog.it/
BLOG STORIE GAY http://nonsologay.blogspot.com/
SITO PROGETTO GAY https://sites.google.com/site/progettogay/
STORIE GAY E NON SOLO https://gayproject.wordpress.com/
BLOG STORIE GAY http://nonsologay.blogspot.com/
SITO PROGETTO GAY https://sites.google.com/site/progettogay/
STORIE GAY E NON SOLO https://gayproject.wordpress.com/
Re: VITA (GAY) DEGLI ANNI '50
Una testimonianza incredibile... Molte cose mi ricordano certi film di quegli anni che ho visto, ma la maggior parte appartiene ad un mondo che mi sembra molto lontano.
- progettogayforum
- Amministratore
- Messaggi: 5980
- Iscritto il: sabato 9 maggio 2009, 22:05
Re: VITA (GAY) DEGLI ANNI '50
L'intera biografia è stata pubblicata in Gay e Storia http://gayproject.altervista.org/storia.pdf all'ultimo capitolo. Si tratta veramente di un documento interessantissimo che permette di farsi un'idea molto concreta degli anni 50-60 e 70.
BLOG PROGETTO GAY http://progettogay.myblog.it/
BLOG STORIE GAY http://nonsologay.blogspot.com/
SITO PROGETTO GAY https://sites.google.com/site/progettogay/
STORIE GAY E NON SOLO https://gayproject.wordpress.com/
BLOG STORIE GAY http://nonsologay.blogspot.com/
SITO PROGETTO GAY https://sites.google.com/site/progettogay/
STORIE GAY E NON SOLO https://gayproject.wordpress.com/
Re: VITA (GAY) DEGLI ANNI '50
Molto interessante questa storia!!! L'unica domanda che ho: l'arco temporale che la storia copre va dagli anni 1950 fino ai primi anni 1970, giusto? Non si sa nulla oltre quegli anni?
- progettogayforum
- Amministratore
- Messaggi: 5980
- Iscritto il: sabato 9 maggio 2009, 22:05
Re: VITA (GAY) DEGLI ANNI '50
Direi che al momento l'arco temporale arriva agli anni 80. Mi auguro che l'autore continui a raccontarsi perché quello che dice è veramente interessantissimo!!
BLOG PROGETTO GAY http://progettogay.myblog.it/
BLOG STORIE GAY http://nonsologay.blogspot.com/
SITO PROGETTO GAY https://sites.google.com/site/progettogay/
STORIE GAY E NON SOLO https://gayproject.wordpress.com/
BLOG STORIE GAY http://nonsologay.blogspot.com/
SITO PROGETTO GAY https://sites.google.com/site/progettogay/
STORIE GAY E NON SOLO https://gayproject.wordpress.com/